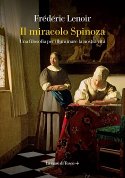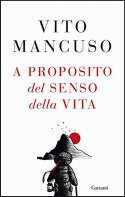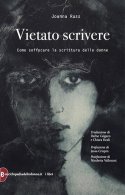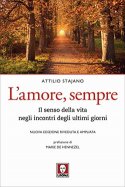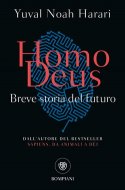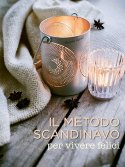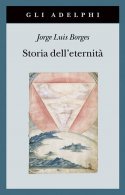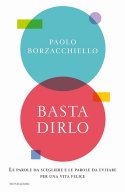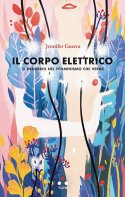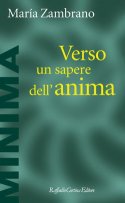Le cose dell'amore
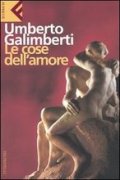
Saggistica
Editore
Recensione Utenti
Opinioni inserite: 1
De rebus amandi
Alla maniera di Lucrezio, perché? Galimberti (Le cose dell'amore, Feltrinelli 2005) ci conduce lungo un percorso classico, tra Socrate, Platone, Nietzsche e Schopenhauer (che alla classicità non erano alieni) e finalmente a Freud e al rapporto con la follia. Questo il percorso dell’amore; ma cosa lungo la strada?
Una ricerca di qualcosa smarrita e uno smarrimento, se quella ricerca non approda a risposte e questo, visto il testo e le sue affascinanti tortuosità, è l’esito più probabile.
L’identità è sia l’oggetto smarrito che l’esito della ricerca, e se Galimberti ne rende improbabile la soluzione accompagnandoci forse troppo tra meandri di pensieri ormai lontani, non manca tuttavia di offrire soluzione, visto che quei meandri altro non sono che i luoghi di un linguaggio diverso che diversamente si è espresso: l’inconscio. E questo è chiaro, se nei meandri non ci siamo persi.
Amare non è scelta: è patimento. L’amore si patisce perché avviene e avviene precisamente nel momento in cui rispecchiamo i nostri frammenti nei frammenti di uno specchio diverso che ci restituisce quel che non sappiamo di essere. Per questo amiamo; non l’altro: noi stessi. Il se stesso che ignoriamo e a cui aneliamo, che rispecchia quell’originaria mancanza a essere cui la simbiosi fin dalla nascita condanna. Amiamo, dunque? No. Potremmo dire che ci identifichiamo con un Ideale dell’Io mai realizzato; per questo idealizziamo e qui sta la follia perché non di idealizzare si tratta, ma di riconoscere. Un testo, allora, che non dell’amore parla ma dell’antiamore, di tutto ciò che non significa amare; se l’Ombra perduta dell’inconscio ci attira, l’altro è irriconoscibile nel suo vero essere; come noi stessi, che non siamo altro che frammenti.
Riconoscere, allora, e nell’incontro con la follia dell’inconscio frammentato, riconoscere è zattera di conoscenza. L’altro anelato è noi e dunque offre occasione di congiungimento con la dimensione della nostra mancanza. E della sua, perché se spogliato da ciò che non gli appartiene, anche l’altro apparirà come è davvero e, nella reciprocità del riconoscimento, ci vedrà finalmente come siamo. Riappropriazione di identità: questo è amore; non dispersione nei frammenti di una follia mai domata dall’amore.