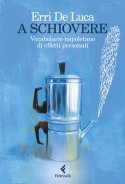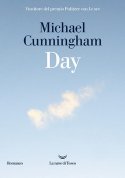Le recensioni della redazione QLibri
| 1719 risultati - visualizzati 401 - 450 | « 1 ... 6 7 8 9 10 11 ... 12 35 » |
Ordina
|
Storie di fanatismo
Edoardo Albinati con Cuori fanatici completa una trilogia, iniziata con Vita e morte di un ingegnere, e proseguita con La scuola cattolica. Il filo comune che lega i tre volumi è sicuramente la memoria, intesa nel doppio senso di tempo storico e tempo privato.
Devo confessare che ho trovato questo libro pessimo. Ho faticato moltissimo a leggerlo, quasi quattrocento pagine lette in ben cinque giorni, con enorme fatica. Una trama che non c’è, personaggi che narrano storie prive di conclusioni logiche, prosa che non segue per nulla i normali costrutti narrativi, priva di una logica ed importante consecutio temporum. E’ un percorso che si snoda, in continuo, di difficile comprensione, composto da continue deviazioni che disorientano il lettore attento e che non comunicano nessun messaggio di senso compiuto. Con tutto che un libro del genere può piacere ad un certo tipo di cultura snob, che dice e non dice.
E’ ambientato, forse, non è così chiaro, diciamo che si intuisce, nella Roma degli anni Ottanta, e narra la storia dell’amicizia tra Nanni e Nico. Loro due danno, così, voce a una fitta serie di ramificazioni costituite da personaggi, storie ed intrecci umani totalmente diversi tra loro, tra letteratura e terrorismo degli anni di Piombo. Perché allora “cuori fanatici”? Che significa? Perché:
“La vita è più forte della salvezza stessa, non se ne sente affatto il bisogno, la reclama solo a parole. Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che ci racconta l’autore hanno tra i venti e i trent’anni, e sono posseduti da una smania inesauribile: di capire, di essere se stessi eppure diversi, di proteggersi e bruciare. Vogliono poter desiderare senza limiti.”
Sono dodici capitoli che iniziano con la descrizione di una città fantomatica, che si presume sia Roma, in cui:
“I ciarlatani riscuotono sempre un discreto successo, l’applauso di incoraggiamento che si tributa al folle incatenato mentre si avvia a salire i gradini del patibolo. (..) Il genio plebeo della città ama i fanfaroni, gli eretici, i radicali, chiunque finisce con la lingua schiacciata dalla mordacchia, e scambierebbe di corsa Gesù per il barone di Munchausen a meno di mostrargli Gesù come una formidabile occasione di spettacolo, un altro estremista pazzo intorno alla cui leggenda esercitare la propria incredulità. (…) Certo che in una città così sembra impossibile che accada qualcosa di interessante, o addirittura che accada qualcosa, dato che gli eventi minuscoli passano giustamente inosservati e affondano nel ronzio indistinto, mentre quelli clamorosi producono, per reazione, un tipo tutto speciale di insofferenza.”
Da qui si passa alla storia del professor Nanni Zingone, professore in un liceo romano, e Nico Quel, consulente editoriale,
“una specie di cortigiano della letteratura.”
Nanni è un fanatico dell’insegnamento,
“Sì davvero il prof. Zingone interrogava, interrogava sul serio, unico a quei tempi, in quel liceo dove persino i colleghi ultrasessantenni avevano abolito voti, compiti, scadenze e ingrate trascrizioni.”
Nico, invece, è figlio di un professore gambizzato ai tempi degli anni di Piombo, del fanatismo che tutto distrugge. La loro amicizia è nata:
“in un museo, ritrovandosi davanti allo stesso quadro e rimanendoci a lungo, da soli, ad osservarlo, uno accanto all’altro. Nanni all’inizio aveva creduto a un approccio omosessuale.”
Di qui in poi la raffigurazione di una pletora di personaggi e di vicende. Storie che vengono narrate, a cui il lettore si fa attento e che ad un tratto finale si interrompono, per dar spazio ad altre voci che narrano di tutt’altro. E così via.
Il libro assomiglia ad una matrjoska, dove l’autore presenta:
“Il ritratto di un’epoca, di una serie di personaggi fanatici che in quell’epoca hanno vissuto il loro fanatismo nei modi descritti.”.
Un libro difficile da leggere, che non mi ha entusiasmato per nulla. Mi dispiace, ma non posso consigliarne la lettura.
Indicazioni utili
“Cosa resta di noi quando perdiamo noi stessi?”
Memoria, radici, sentimenti: sono questi i temi attorno al cui intreccio si muovono i personaggi del nuovo romanzo di Michela Marzano, edito nelle scorse settimane da Einaudi.
Un romanzo bellissimo, intenso, a tratti struggente, che racconta non una ma due storie parallele, seppur appartenenti a dimensioni temporali differenti: una è quella della voce narrante, Alessandra, una quarantenne italiana trasferitasi da molti anni in Francia per sfuggire al peso insostenibile dei ricordi legati a una drammatica vicenda familiare e lasciati nel suo assolato Salento; l’altra, invece, è quella di Annie, l’anziana madre del compagno della stessa protagonista, la quale viene colpita da un disturbo neurodegenerativo che erode senza pietà ricordi e affetti della sua esistenza passata. È a lei che si riferisce quell’ “idda” che riecheggia quasi misteriosamente nel titolo e il cui suono e significato (“lei”, in dialetto pugliese) riemergono all’improvviso dal pozzo del tempo e delle parole identitarie in verità mai dimenticate. Due donne diverse, figlie di epoche lontane, due vicende in apparenza slegate che però, proprio quando sembra che tutto sia finito per via della malattia di Annie, troveranno un punto d’incontro inatteso attraverso uno di quei piccoli grandi miracoli con cui la vita talvolta può sorprenderci.
Particolarmente coinvolgente e profonda, la scrittura dell’autrice ci consegna un’unica storia dai tanti volti che affronta con coraggio anzitutto il tema della malattia negli anni della vecchiaia - la si chiami Alzheimer, demenza senile o in altro modo - mettendo ben in evidenza sia l’estrema fragilità di chi la vive in prima persona sia lo spaesamento, e forse anche la non completa accettazione, da parte dei familiari. “Che cosa resta di noi quando perdiamo noi stessi?” ci si domanda con angoscia di fronte a un evento di tale portata che fa sì che non si riconoscano nemmeno le persone più care; e poi, raggiunta una certa età, chi dice che non si possa avere “diritto” al decadimento mentale? Difficile dare una risposta certa a interrogativi tanto inquietanti perché, come dimostra Alessandra, abbiamo tutti paura di perdere il controllo sulla nostra vita, di non riconoscere gli altri né, tanto meno, riconoscerci.
“Chi siamo davvero? E se la verità fosse altrove, diversa rispetto a quello che pensiamo? E se la parte autentica di ognuno di noi fosse nascosta proprio finché ci sforziamo di controllare tutto, perché ci sono tante cose da fare e non possiamo permetterci il lusso di essere, semplicemente essere, stanchi, depressi, svogliati, capricciosi, noiosi, persino sbagliati e dementi, ecco sì, questo: dementi?”
Tutto ciò, naturalmente, non può non ricollegarsi al tema del passato, quella preziosa identità individuale che, nel bene e nel male, fa parte di noi rendendoci quel che siamo e senza la quale non si può vivere appieno il presente né costruire il futuro. Non lo si può rinnegare, il passato: per quanto lontano si provi ad andare, per quanto si cerchi di ricominciare daccapo altrove rivestendo il cuore d’un manto d’oblio forzato, ce lo porteremo sempre dietro e presto o tardi dovremo affrontarlo perché “[…] il passato non passa mai, e la pace è sempre impastata di rimpianti e recriminazioni.”
Ottima la caratterizzazione dei personaggi, sia femminili che maschili; molto ben curata l’introspezione psicologica che scava nelle emozioni, nei sentimenti, nelle paure in particolare di Alessandra, in quel suo disperato rifiuto di diventare madre che potrà superare soltanto allorché si riconcilierà con la propria storia di figlia.
Un lungo e tormentato viaggio che ricostruisce esistenze ed essenze smarrite e, con tono spesso disarmante, racconta la forza dell’amore che, alla fine di tutto, è la sola cosa che ci appartenga veramente e rimanga per sempre.
“Ci sono cose che, sebbene l’amore che ci lega a una persona sia più profondo di un oceano, non possono essere né dette né spiegate. Nemmeno la persona che amiamo può ripagarci dei torti dell’esistenza. Lo sbaglio peggiore che si può commettere è attribuirle il potere di riparare la nostra vita.
Ma ci sono anche cose che dovrebbero sempre essere dette, pure quando mancano le parole e si è certi di non essere capiti. Altrimenti pian piano ci si allontana, si spalanca la voragine dell’incomprensione, e persino l’amore più grande viene consumato dall’indifferenza. ”
Indicazioni utili
Naxos
«Ho capito che nessuno di noi, purtroppo, può evitare che i nostri figli si sentano derubati da quello che noi saremo o non saremo, gli daremo e non gli daremo… Però se noi, adesso che siamo solo all’inizio, non ci diciamo bugie, se facciamo lo sforzo di rimanere saldi e non permettiamo all’Uragano Figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri, oscuri desideri, se non trasformeremo i nostri figli nella scusa per perdere definitivamente il contatto con quello che davvero siamo, anche se è scomodo, soprattutto se è scomodo, io penso che quando un giorno loro ci chiederanno: che cosa è successo, mamma?, come mai qui, nella mia testa, è tutto per aria? Perché la serratura del mio cuore è stata scassinata, papà?, bè: almeno una risposta da noi ce l’avranno, e non dovranno andare a cercarla da un analista, dall’amore, da una guida spirituale, dall’amore, dai fiori di Bach, dall’amore.» p .23
Quando all’uscita del locale ha conosciuto quello strano soggetto che sin dal principio l’ha approcciata con rudezza e con un soprannome, Occhi, perché quel verde era indescrivibile e alla fin fine nemmeno il resto era poi da buttar via, ella già sapeva che tutto sarebbe finito con quel fare l’amore così naturale e spontaneo che soltanto certi incontri hanno il potere di avere. Stefano era così, è sempre stato così. Nonostante i suoi tradimenti, i suoi alti e bassi, i suoi giorni fissi su PERICOLO BLU dove ogni pretesto era buono, il suo cadere in ogni tipo di droga dalla cocaina alla ketamina passando anche e non di meno per l’eroina, nonostante quella relazione che era chiaramente diventata una terra pericolosa, un Far West dove tutto era lecito per giustificare quel dolore, quel vuoto, quella super eccitazione, per lei nessuno poteva sostituirsi a quel primo grande e devastante amore con cui aveva realizzato i suoi primi libri, con cui aveva disegnato i suoi primi eroi per bambini. Anche adesso che aspetta un figlio da Damiano Massimini, quello stesso psicologo con quindici anni più di lei, la sua barba che pare fatta di polvere che lo fa sembrare più anziano rispetto a quegli occhi chiari, vigili e attenti che sono quelli di un ragazzino che prese in cura proprio quel primo amore, non può far a meno di pensarvi. E poi, poi c’è Di che è stato l’unico a toccare realmente le sue corde più intime, tanto da farla restare invece che, come suo solito, fuggire. C’è Naxos, “un’isola strana, dove le storie cominciano, passano, ma non si chiudono mai, perché c’è sempre qualcuno che si inventa un finale diverso e così tutto ricomincia da capo, come in un eterno presente” (pag. 212). C’è l’esser diventata madre con tutto quel che ne compete, l’esser fragile e al contempo indistruttibile. Chi sono io? Chi ero? Perché sono qui? Perché è così difficile considerarsi una famiglia? Cosa ha davvero significato quell’isola e perché un’assenza può essere più forte e dirompente di una presenza, perché le possibilità possono farci così tanta paura da sembrarci irrimediabilmente pericolose e lesive?
Partendo dal mito dell’abbandono di Teseo e Arianna e con un’eroina molto particolare il cui cuore è suddiviso tra tre uomini, che ha paura, paura di perdere il filo, di perdere le sue certezze, Chiara Gamberale torna in libreria con un libro intriso di molteplici tematiche e di spunti di riflessione. Tutto ha inizio con una seduta in un gruppo di psicanalisi e continua con l’intento di scrivere una lettera al figlio per spiegare quei perché, per dare quelle risposte a cui si somma, ancora, un’autoanalisi che passa dal presente al passato per tornare alla dimensione di Naxos e riuscire ad affrontare quelle fatali trasformazioni che la vita, con la sua durezza, la sua crudeltà, la sua inarrestabilità, semplicemente ci mette davanti. Travolgendoci, destabilizzandoci. Perché qualcuno nasce, altri muoiono, altri si separano da noi per molteplici circostanze, altri restano. Ed è difficile mantenere il controllo quando la nostra esistenza ci sfugge, è inafferrabile. È difficile sapere chi siamo quando tutto quello che sempre ci ha caratterizzato va in frantumi come un vetro di cristallo.
Come fare allora per affrontare tutto questo? Come uscirne indenni? Come rinascere? Prima di tutto occorre conoscersi, sapere chi siamo e solo una volta che tale consapevolezza è sopraggiunta, soltanto quando siamo consapevoli dei nostri limiti e delle nostre colpe, soltanto quando ci assumiamo le responsabilità dei nostri errori senza scaricarli su terzi, allora possiamo dire di avere una possibilità di riuscire. Allora possiamo essere certi di poter amare davvero senza essere schiavi di quella persona impossibile con cui ci facciamo scudo, ci proteggiamo, che diventa lo specchio della nostra insicurezza, dei nostri sbagli, della nostra mancanza.
Questo e molto altro è “L’isola dell’abbandono”, un testo dove siamo chiamati ad interrogarci sui nostri timori, sulle nostre debolezze, sui nostri successi e insuccessi. Ancora, in questo, vengono affrontate problematiche quali la paura di restare di fronte alla possibilità di fuggire, la difficoltà di assumersi le proprie responsabilità, la paura di sbagliare, l’evoluzione, la maturazione dell’essere umano. Perché tutti abbiamo dubbi, tutti abbiamo preoccupazioni, ma possiamo sempre migliorarci, crescere, di affrontare le nuove difficoltà e esperienze della vita. E questo è quello che Chiara e la sua protagonista fanno. Imparando a prendersi cura di loro stesse, imparando a prendersi cura dei loro bambini, imparando semplicemente ad amare con semplicità e genuinità.
Un contenuto forte a cui si associano deliziose illustrazioni (quali il coniglietto Pilù: che fa su e giù) e uno stile narrativo che o si ama o si odia. La prima parte, in particolare è molto descrittiva, prolissa e talvolta confusionaria perché la scrittrice catapulta il lettore interamente nella mente caotica di questa neo madre, ma superata questa il messaggio del testo arriva nella sua totalità e non lascia indifferenti.
«Lei dà un bacio sulla fronte anche a lui. Poi prende Emanuele in braccio, fa finta di mordergli un piedino, l’altro. Gli sussurra in un orecchio: “Ciao amore. Sono tornata”. Lui le afferra un dito con una mano. Con gli occhi cerca Damiano, lo trova. E si calma. Misteriosamente, come misteriosamente si era turbato.
Ma se sapessimo di che cosa abbiamo bisogno, non avremmo bisogno dell’amore. »
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
"Sono io la tua mamma."
Malone ha poco più di 3 anni ed una fantasia molto fervida: racconta storie di pirati e navi fantasma, castelli e cavalieri e razzi che volano verso pianeti lontani. Il suo migliore amico è un peluche con le sembianze di un aguti, uno strano roditore che vive nelle regioni tropicali dell'America, Guyana in particolare: sono inseparabili Malone ed il suo peluche 'Guti', giorno e notte sempre insieme, la notte soprattutto, quando sotto le coperte, al riparo da tutto e tutti, Guti racconta quelle favole che a Malone piacciono tanto, sempre le stesse favole, una per ogni giorno della settimana, racconti che Malone ha imparato a memoria parola per parola perchè lo aiutano ad essere più forte, più coraggioso, dimenticando - anche se solo per un momento - ciò che più lo terrorizza: la pioggia, con quelle gocce di vetro che lo colpiscono dappertutto lacerandogli la pelle, ed il buio quando chiude gli occhi e si colora progressivamente di rosso, rosso sangue.
Ma tutto ciò non avrebbe insospettito lo psicologo infantile Vasil Dragonman se Malone non avesse detto alla sua maestra che la madre, Amanda Moulin, non è sua madre.
E i ricordi che il bambino ancora conserva di colei che ritiene essere la sua vera mamma e dei momenti della sua vita trascorsi insieme e schematizzati nei suoi disegni, per quanto confusi, per quanto alterati dalla sua immaginazione, incuriosiscono lo psicologo a tal punto da non arrendersi di fronte l'evidenza delle foto di famiglia che ritraggono il piccolo Malone appena nato con Amanda e suo marito Dimitri o dinanzi alle testimonianze del medico pediatra e dei vicini di casa; anzi Vasil, solo contro tutti, riesce a coinvolgere la comandante della polizia locale Marianne Augresse affinché possa aiutarlo a scoprire la verità su Malone prima che la sua memoria, sin troppo volatile come accade in tutti i bambini di quella età, rimuova completamente quelle immagini e con esse il ricordo dell'altra mamma.
Michel Bussi, autore francese dell'alta Normandia, dove è ambientato questo romanzo come diversi altri della sua bibliografia, si conferma ancora una volta uno dei migliori scrittori di thriller contemporanei, come testimoniano anche i vari riconoscimenti da lui ricevuti a livello internazionale.
"La doppia madre" è un romanzo che non lascia scampo al lettore, avviluppandolo nelle sue trame e tra le sue pagine che scorrono rapidissime come un fiume in piena e altro non si può fare se non lasciarsi trascinare dalla sua corrente: il mistero di Malone ed il tentativo di scavare nella sua mente per riportare alla luce quel mondo a cui il bambino resta ancorato da un appiglio molto labile si intreccia in modo inaspettato e mirabilmente architettato con l'indagine guidata dalla stessa comandante Augresse per la cattura di un gruppo di banditi e del loro presunto capo Alexis Zerda a seguito di una rapina a mano armata. Due storie apparentemente disgiunte che progressivamente si riveleranno invece accomunate da uno stesso denominatore: l'amore di una madre, sia esso reale verso un proprio figlio o immaginario, verso un figlio desiderato e mai ricevuto, o perso per sempre.
Un sentimento così intenso che non teme ostacoli se messo alla prova: e se, da una parte, esso rende una donna coraggiosa e temeraria pur di proteggere un bambino come se fosse quel figlio che non potrà più avere, dall'altra può anche portare una donna alla follia, trasformandosi da madre in doppia madre.
"Quando si vuole bene a qualcuno, ma bene sul serio, certe volte bisogna avere il coraggio di lasciarlo andare lontano o di saperlo attendere a lungo. E' una vera prova d'amore, forse l'unica."
Indicazioni utili
Le favolette del Re
Negli ultimi anni siamo abituati a vedere almeno un paio di nuove uscite, partorite da una delle penne contemporanee più amate. Mentre la fine del 2018 era stata segnata da "The Outsider", prima nota piacevole (a dir poco) dopo anni di oblio, nel 2019 King fa il suo esordio con un piccolo libricino; un racconto, che secondo me è più una favoletta con tanto di piccole morali. Nel momento in cui mi sono reso conto che "Elevation" era un libro di questo genere, devo dire che ero piuttosto fiducioso: uno dei migliori autori contemporanei che si cimenta in qualcosa che può trasmettere un bel messaggio, era qualcosa che mi entusiasmava. Ho addirittura pensato: "vuoi che abbia deciso di partorire qualcosa di fortissimo, che si tramandi ai posteri come il Piccolo Principe è arrivato a noi?"
Sì, ragazzi, d'accordo, ho esagerato; ma non mi date addosso.
Inutile aggiungere che le mie speranze erano totalmente vane, e che in fondo questo non è altro che un raccontino neanche troppo bello. C'è la mano di King, e questo si nota soprattutto dall'elemento fantastico (del quale non ho capito molto l'utilità) che è di impronta assolutamente kinghiana, ma che secondo me non è stato ben sfruttato. Si poteva fare molto meglio.
Scott è un uomo di mezza età che un giorno scopre di avere uno strano problema: sta perdendo tantissimo peso, ma la sua stazza fisica rimane sempre la stessa. È come se semplicemente la forza di gravità stesse smettendo di esercitare la sua influenza su di lui. Scott si confronta con un medico in pensione, che gli consiglia di farsi visitare da alcuni esperti, ma entrambi sanno che diventerebbe una cavia da laboratorio; un fenomeno da baraccone. Allora la nuova condizione di "malato terminale" spinge Scott a vivere la sua vita svestendosi di ogni paura, cercando di lasciare un buon ricordo di sé. Castle Rock è un paesino pieno di pregiudizi che lui proverà a combattere a beneficio delle sue nuove vicine di casa. Una di loro è tutt'altro che benevola, nei suoi confronti, ma Scott proverà in tutti i modi a fare breccia nel suo cuore; a farle capire che tra gli uomini ci saranno anche bestie della peggior specie, ma ci sono anche persone buone.
Il tema dei pregiudizi, che alla fine è quello centrale del racconto, è un po' abusato al giorno d'oggi. Oltretutto, i personaggi sono quasi bidimensionali. Certo, non è facile caratterizzare bene un personaggio in poche pagine, ma da King ci si aspetta qualcosa di più di: una donna lesbica arrabbiata con un mondo pregiudizievole, che rifiuta a prescindere anche la gentilezza di un vicino totalmente disinteressato. Oltre a essere un po' forzato il modo d'essere dei protagonisti, è un po' forzato anche il loro stravolgimento.
Forse è blasfemia citare autori come Dostoevskij e Thomas Mann, ma loro certamente ci dimostrano che dar vita a personaggi forti in poche pagine si può, come dimostrano i loro "Le notti bianche" e "La morte a Venezia"; certo quest'ultimo non l'ho amato, ma non si può negare che il protagonista sia ben tratteggiato.
Ora, caro Stephen, tu sei a un bivio: ci hai lasciato tante opere memorabili, ma io so che puoi scrivere la tua "storia definitiva", quella per la quale sarai sempre ricordato. Lo pretendo, perché so che ne sei capace. Non è un obbligo verso i lettori, ma verso te stesso. Qualcuno mi dirà che questa storia è già stata scritta e mi citerà i titoli più disparati... e forse è vero. Forse "la storia definiva" è già stata scritta, ma ogni volta che comincio un nuovo libro del Re sento dentro di me questa strana sensazione.
Sarà il tempo a dire se mi sbaglio o se King ci sta solo facendo aspettare.
"Tutto converge in questo continuo levitare, pensò. Se è questo che si prova morendo, ognuno di noi dovrebbe essere ben lieto di fare il passo estremo."
 Opinione inserita da ornella donna 25 Febbraio, 2019
Opinione inserita da ornella donna 25 Febbraio, 2019
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Le difficoltà amorose e le protezioni
Marco Missiroli, dopo aver pubblicato Atti osceni in luogo privato, con cui ha vinto il Premio Super Mondello, torna in libreria con Fedeltà, un libro che già dal titolo racconta molto del suo contenuto. Un libro in cui si respira sin dall’inizio un senso di attesa, di incompletezza, di sospensione, di un qualcosa che si vorrebbe accadesse ma che non si se accadrà mai.
Narra, con particolare sottigliezza e acume, la storia tra Margherita e Carlo. Lei immobiliarista, lui docente universitario per merito del padre. Un giorno vengono sorpresi, lui e una sua allieva, Sofia, nei bagni dell’università. Lui si difende dicendo che la stava soccorrendo, in seguito ad un suo malore. La verità? Mah. Si intuisce: Sofia che scrive un solo racconto, la gioventù, la libertà. A sognare di lei non può che essere Carlo, in una dimensione altra, differente dalla normalità. Nel frattempo anche Margherita desidera: a causa di una dolorosa pubalgia si reca in un centro massaggi, dove conosce Andrea, uomo dai molti segreti e dalle mille sfaccettature. Il cuore di Margherita è un po’ malconcio e lei si sente come:
“Churchill che si prende un giorno di ferie durante la Seconda Guerra mondiale.”.
Intanto si bea e si perde negli occhi di Andrea, sente su di sé le mani di Andrea e vorrebbe che si mutassero in carezze, in coccole più profonde. Tutto è un dubbio. Il tradimento dei due, sia di Carlo che di Margherita, è solo un mero pensiero o un atto consumato? Infatti:
“Ciò che è stato, ancora è”.
Il confine è sottilissimo, e gioca sull’ambiguità:
“Che parola sbagliata, amante. Che parola sbagliata, tradimento.”
Che cosa è la fedeltà?:
“la fedeltà è un’àncora che ci permette di non essere travolti nella tempesta, ma è anche lo specchio in cui ci cerchiamo ogni giorno sperando di riconoscerci.”.
E allora è gioco forza domandarsi: dichiarare resa alla comprensione o insistere a volersi riconoscere anche nel matrimonio?
“Adulterio contro adulterio: io l’ho fatto ma anche tu probabilmente l’hai fatto. Aveva lasciato depositare il sospetto, discolpandosi un poco dei propri inganni, infastidendosi, ingelosendosi, trattenendosi. “.
Tra una Milano vivida che ricorda i racconti di Dina Buzzati e una Rimini poetica, la narrazione si dipana con sentimento e schiettezza. Un romanzo intimo ed intimistico, che scruta con forza nei legami tra esseri umani, facendo forza sulla loro intrinseca insicurezza. Il narrato è profondo, la prosa ha un taglio poetico che scruta a fondo i pensieri e le emozioni dei protagonisti, trascinando il lettore in una lettura colta e dotta. Una lettura di classe e profondità.
Indicazioni utili
Una nuova avventura per Fra'Svampa
Egitto, Deserto a sud-est dell’oasi di Siwa, 22 gennaio 1616. Kitab e Butrus. La fortuna o forse la malasorte, uno strano luogo, una cassa oblunga realizzata in legno e inserita in una nicchia scavata nella roccia, una maledizione, una maledizione di pietra.
Roma, via Giulia, anno del Signore 1625, 23 Novembre. Fra’ Girolamo Svampa che ha ancora i conti aperti con Gabriele Salluzzo, suo nemico mortale, viene coinvolto nell’indagine su una suora benedettina, suor Matilda, figlia del suo bravo Cagnolo Alfieri, il quale non credendo alle supposizioni di una fuga volontaria per amore attraverso una rocambolesca arrampicata nella ceppa del camino, il più grande, oltretutto, dei disonori, rischia la forca per essersi illuso di poter raddrizzare, facendosi giustizia da solo, il torto subito. Per salvarlo da morte certa e per il legame che li unisce Girolamo cerca di ritardarne e evitarne la condanna capitale e cerca di far luce su una sparizione che è tutt’altro che chiara.
Giunto nella città ambrosiana l’inquisitore si rende contro sin dal principio di trovarsi di fronte ad un muro di silenzio e di menzogna. Prima a mentire è niente meno che Suor Teresa, colei che all’interno della dimensione della clausura è chiamata a rivestire i ruoli più autorevoli di controllo e di umanità. Per riuscire a far luce sui fatti lo Svampa non può fare a meno che chiedere aiuto a Margherita, la femme fatale dai lunghi capelli rossi che non esita un attimo dal tentarlo al peccato. E sarà proprio grazie al suo aiuto che l’inquirente verrà alla luce non di uno bensì di due misteri: un primo avente ad oggetto una monaca deceduta e rinvenuta in uno stato di pietrificazione, un secondo avente ad oggetto una monaca murata viva in una cripta per aver ceduto alla carne. Chi è questa seconda religiosa? Non è niente meno che suor Virginia Leyva, figlia di don Martino de Leyva y de la Cueva-Cabrera, conte di Monza e amico del re di Spagna, ovvero la celebre Monaca di Monza. Un doppio enigma a cui si aggiunge un misterioso pedinatore, due uomini maledetti in un deserto non poi così lontano, uomini alla ricerca di giustizia, un ampio spazio-temporale e geofisico.
«La capacità di descrivere è una qualità rarissima, spesso soppiantata dalla pretesa di riportare agli altri non quel che abbiamo visto, bensì quel che crediamo di aver visto o, ancor peggio, quel che vorremmo aver visto.» p. 140
Con una penna rapida, fluente, precisa e erudita, Marcello Simoni torna in libreria con un nuovo capitolo delle avventure dedicate a fra’ Girolamo Svampa e dona al lettore un testo di grande piacevolezza che conquista sin dalle prime battute. L’opera è caratterizzata da un intreccio narrativo solido, lineare, logico, con personaggi ben strutturati, ma è anche ricco di ponderati colpi di scena che incuriosiscono il conoscitore tanto da indurlo a divorare il componimento.
Simoni conferma la forza del suo personaggio attraverso un elaborato stratificato e nuovamente di gran fascino e originalità. Una lettura godibilissima.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il primo Re
Il lavoro e gli studi di Andrea Carandini, per quanto ancora discussi, hanno gettato una nuova luce sulla figura mitica di Romolo e sulla fondazione di Roma. Tuttavia, se anche oggi si può nutrire una maggior fiducia sul fatto che, alla metà dell’VIII secolo avanti Cristo, sia effettivamente esistito un uomo che diede origine a quella che di lì a qualche secolo sarebbe divenuta la più famosa e potente città del Mondo conosciuto, quel personaggio e la sua storia restano ancora avvolti nelle nebbie della leggenda. Di Romolo non sappiamo molto di più di quanto ci narrano gli Annales e le coeve storie agiografiche della Roma dei Cesari che avevano tutto l’interesse ad avvolgere i natali dell’Urbe di un’aura semi-divina, a cominciare dalla paternità del primo re.
Franco Forte e Giulio Anselmi provano a ripercorrere la storia del fondatore riempiendo i fantasmi descritti nel mito con i muscoli e il sangue di esseri umani che vissero e soffrirono in un’era dura e pericolosa. Li animano con sentimenti e passioni. Riviviamo, così, grazie a loro, quella storia fatta di tormenti e di slanci eroici, ma pure di bassezze e inganni. Siamo fatti partecipi dei loro idealismi e sogni di gloria, ma pure delle insicurezze e dei dubbi che agitano ogni uomo che ignora il proprio futuro e non si aspetta certo di divenire leggenda.
In questo romanzo storico, scritto con uno stile agile e scorrevole, ritroviamo i nomi che studiammo sui banchi di scuola, a cominciare dalla bellissima vestale Rea Silvia messa incinta dal dio Marte (secondo la leggenda) o, più umanamente, dall'amante che nascostamente l’andava a trovare nel tempio dedicato a Giove, ove questa era stata rinchiusa dallo zio Amulio che di lei abusava sin dalla tenera età. Rivediamo Numitore, il padre imbelle, incapace di difenderla dagli abusi del fratello, usurpatore del suo trono. Partecipiamo dei dubbi di Faustolo, il pastore che crebbe i due gemelli assieme alla moglie Acca Laurentia, e che si trovò a dover gestire, con il solo buon senso dell’uomo comune, una situazione assai più grande di lui. Poi, ovviamente, seguiamo le vicende di Romolo e Remo, sino al dissidio finale che porterà a morte il più esuberante dei due, l’inquieto Remo. Partecipiamo alle prime scorrerie della neonata civitas, al ratto delle ragazze sabine, alle guerre con i villaggi limitrofi e al consolidarsi di quelle istituzioni pubbliche che contraddistingueranno la Città-stato per i secoli a venire.
Il racconto fluisce rapido attraverso un panorama ben conosciuto e senza soverchi colpi di scena calcando le orme già tracciate dai narratori del passato. Forse, proprio questo è il difetto maggiore. Gli AA. non ha avuto il coraggio di distaccarsi da ciò che ci narra la tradizione storiografica classica. Romolo e Remo, Tarpeia, Tito Tazio, Osto Ostilio, non ci sono mostrati per nulla diversi da come ci erano stati raccontati dai libri di storia romana. Questo pedissequo accodarsi alle fonti classiche toglie spessore ai personaggi che ci appaiono un po’ troppo convenzionali, meno concretamente umani. Romolo è troppo generoso ed altruista. Remo troppo il Caino della situazione. La divisione tra i buoni, che forniranno di ottime fondamenta morali l’Urbe, e i cattivi, biechi e perversi, è eccessivamente manichea.
Se gli AA. avessero osato riscrivere le vicende concedendosi maggiori licenze e lasciando più libera l’inventiva forse il racconto ne avrebbe tratto giovamento, divenendo esso più seduttivo e i personaggi più credibili e concreti. Così, invece, ne è risultata una vicenda epica, ma convenzionale; timidamente rispettosa della traditio.
Comunque è un’opera sicuramente apprezzabile che si legge rapidamente e con piacere. In un’epoca in cui i programmi scolastici prevedono solo lezioni di “geo-storia” nelle quali non si impara bene né la geografia, né la storia, unire al lato meramente avvincente e ricreativo anche un valore didattico è un’operazione tutt'altro che disprezzabile. E questo è un ulteriore punto a favore di questo libro, consigliabilissimo.
Indicazioni utili
L'America Post Apocalittica
Sulla scia del grande successo prima fiacco e poi fortunato (grazie alla trasposizione cinematografica) di “Fight club”, classe 1996, Chuck Palahniuk torna in libreria con “Il libro di Talbott” (Mondadori), opera che di questo successo d’esordio ha molto ma che al contempo si spinge oltre, portando alle massime conseguenze le vicende e gli eventi. Tutto ha inizio a causa di un libro nero-blu, un pamphlet, che circola a macchia d’olio tra le persone enunciando e siglando direttive rivoluzionarie e annunciando l’imminenza – tramite la voce degli spot pubblicitari di Talbott Reynolds – del cd “Giorno dell’Aggiustamento”. In vista di ciò un gruppo di ragazzi come tanti crea una lista di persone da uccidere, o comunque da privare di un orecchio (e per la precisione, che sia l’orecchio sinistro!); uomini e donne che fanno parte dell’èlite della società americana essendo politici (la cui colpa è quella di mandare in guerra una intera generazione di giovani, in parte perché difficili e quindi ingestibili, in parte per far fronte al sovraffollamento degli esemplari maschili rispetto ai femminili, dunque, da ciò, perché studiare, perché impegnarsi se sei già uno zombie che cammina, tanto vale sballarsi con droghe, sesso e alcol), professori (che rappresentano i detentori del pensiero e che per questo hanno commesso il reato di indurre a pensare, a riflettere, ad interrogarsi e da qui, male ai libri che sono il nemico per eccellenza), giornalisti, notabili e chi più ne ha più ne metta, l’importante è alimentare l’odio. Perché questa lista e i principi di questo libro circolano nel web, cadono in balia degli Haters diventando un mantra inarrestabile.
Ma non è ancora finita, per niente. Perché mentre questa ribellione ai potenti da parte di chi ha deciso di non esser più carne da macello per l’ennesima guerra in Medio Oriente si diffonde, contemporaneamente, con la Dichiarazione di Interdipendenza, gli ormai ex Stati Uniti vengono ridefiniti nel loro essere attraverso criteri razziali che distribuiscono e suddividono gli abitanti in base al colore della pelle, alle preferenze sessuali, alle idee. Il risultato ultimo è la creazione di tre nuovi stati-nazione: la Caucasia (dove vengono confinati i bianchi), Blacktopia (lo stato destinato alle persone di colore) e Gaysia (ex California ad oggi dedicata esclusivamente alle persone omosessuali, un po’ come la Grecia nell’opera di Fabio Canino, classe 2016, intitolata “Rainbow Republic. Romanzo distopico gay”, ma con le dovute differenze). Tra le conseguenze di questo fenomeno vi è l’esodo degli ex statunitensi verso il Messico, Messico che chiude le frontiere per il surplus di esuli americani, i quali, pertanto sono costretti a vivere in un inferno senza via d’uscita. A movimentare una trama già di per sé fortemente articolata, si aggiungono una serie di circostanze e vicissitudini che romperanno il disequilibrio creato, perché questa America post apocalittica deve dire la sua e ha ancora molto altro da dire.
Una vera e propria satira è “Il libro di Talbott” del noto freelance statunitense, un elaborato intriso di paradossi, intriso di vicende portate ai massimi estremi del loro essere, intriso di una miriade di personaggi presentati in modo irregolare, senza, quasi, un filo logico di congiunzione. Questo è determinato anche dal fatto che lo scrittore tende a mutare voce narrante di paragrafo in paragrafo, presentandoli quasi tutti insieme, e di poi, distanziandoli e rimescolandoli e reintroducendone di nuovi nel proseguire del testo. Il conoscitore, dunque, soprattutto nella prima parte, fatica un po’ ad entrare in sintonia con il componimento anche perché non solo mutano gli elementi anzidetti, ma varia anche lo stile adottato a seconda del protagonista narrante che assume connotati tipicamente adolescenziali, abbreviati e troncati (vedi ‘sto) con le voci più giovani e autorevoli con quelle più adulte. Non solo, a ciò occorre aggiungere che poiché lo scritto è una vera e propria ironica derisione degli Stati Uniti che vengono analizzati e scrutati con un occhio ipercritico che nulla lascia al caso e che nulla vuol risparmiare, ancora più complesso è per chi vi si avvicina da oltreoceano conoscere e coglierne ogni sfumatura.
Altra nota che non passa in secondo piano è certamente il costante riferimento ad autori della fantascienza del ‘900 e alle opere relative. Tra queste spicca costantemente senza remore “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury.
In conclusione, “Il libro di Talbott” è un distopico impegnativo, con molteplici significati e spunti di riflessione, adatto a chi conosce molto bene la società americana e a chi ama il genere. Il rischio è altrimenti è quello di cadere vittima di questa prolissa e stratificata impalcatura narrativa tanto stilistica che contenutiva.
Indicazioni utili
- sì
- no
No = a chi non ama il filone, a chi non è interessato alla tematica e/o non apprezza questo tipo di stile narrativo.
Una piacevole sorpresa
C'è da premettere che non sono una persona che si scervella troppo sugli avvenimenti politici che avvolgono l'Italia. Certo, non provo molta simpatia né stima per le persone che attualmente guidano il Paese, persone che non si fanno il minimo problema a nascondere la propria ignoranza su determinati argomenti, spesso sparando giudizi o facendo proclami che non hanno alcun fondamento logico né che denoti una minima conoscenza di ciò di cui si parla; ma questo è un atteggiamento che mi urta indipendentemente dalla politica. Oltretutto, la disumanità che queste persone stanno dimostrando giorno dopo giorno non fa altro che rendere il quadro più squallido e preoccupante.
Questo libro si concentra proprio su questi aspetti, su qualcosa che oggi stiamo vivendo e toccando con mano, e credo lo faccia in maniera efficace, mettendoci in condizione di ridere ma anche di riflettere. Ci sono tantissimi rimandi alla nostra attualità: ci sono i "buonisti" e i "pietisti"; c'è la propaganda feroce e disinibita tramite social e l'offendere quel che non si può contrastare con la logica; c'è un Ministro dell'Interno amato dal popolino che ragiona con la pancia (chissà chi è); c'è un Italia che ormai si è disabituata a ragionare con la propria testa per seguire i propri istinti e coloro che questi istinti sanno scatenare.
Giacomo Papi si rivela una buona penna, con uno stile fluido e piacevole da leggere; ma credo proprio che i sostenitori di Salvini e company (ops, ho detto il nome, vabbè chissene) non apprezzeranno molto questa lettura. Chi ha un minimo di sale in zucca la apprezzerà o quantomeno saprà prenderla con un po' di filosofia.
Gli intellettuali sono le prossime vittime delle ire del governo e del popolo. Dopo gli immigrati, i rom e gli omosessuali è il turno di quelli che "si sentono più intelligenti degli altri": i radical chic.
La cultura è difficile, noiosa, complica le cose; dunque va eliminata.
Il primo a fare le spese di questa forma mentis è il professor Giovanni Prospero, insegnante che viene ucciso a suon di botte per aver citato Spinoza durante un talk show. L'assassinio di Prospero è soltanto l'inizio di quella che sarà una vera e propria soppressione della cultura, delle parole e dei concetti difficili che il popolo non può e non vuole comprendere. Dato che il popolino viene prima di tutto, queste cose vanno eliminate. Parte dunque una censimento degli intellettuali, che dovranno iscriversi a un programma di protezione (che sarà pagato di tasca loro, il popolo non deve cacciare un euro per i "diversi").
Giacomo Papi ci racconta una realtà scomoda e ai limiti del surreale, ma che al lettore accorto risulterà spaventosamente familiare. La non tanto velata citazione a Fahrenheit 451 fatta nelle ultime pagine (ti ho scoperto, Papi) è quasi un grido d'allarme, per farci comprendere che noi esseri umani non solo siamo capaci di ripetere gli stessi errori del passato, ma siamo in grado di farne anche di peggiori.
"Perché le emozioni sono facili, elementari. Se impari i trucchi, le puoi governare, mentre i pensieri rimangono liberi, vanno dove dicono loro e complicano le cose. Dove comanda la ragione, la statistica muore."
Indicazioni utili
La spada di ghiaccio
Romanzo d’esordio di Bolano, veramente bellissimo. E’ stato classificato come thriller ma non è naturalmente un giallo classico, forse nemmeno un giallo. E’ una cosa inclassificabile, originalissima, forse più romanzo sentimentale che giallo, ma sentimentale senza zucchero, anzi con un po’ d’aceto. Anche se nella narrazione si intrecciano più voci, più storie d’amore o quasi, la voce più interessante è senza dubbio quella del geniale e arrivista Enric Rosquelles, uomo in carriera, poliedrico, pieno di interessi e tutto cervello. E’ bellissima perché Bolano rende la sua voce particolarmente brillante, geniale, scafata in tutto, ma del tutto innocente e idealista in amore fino al limite massimo consentito. Fino a voler vivere una storia d’amore senza mai viverla, facendola muovere come in una pista di ghiaccio nel territorio dell’idea e del sogno in modo da renderla atemporale, forse eterna. Come un filo che si tende al massimo e poi… vedrete voi la fine. La storia sembra non avere nessuna possibilità. Enric è un uomo grasso e poco dotato fisicamente mentre Nuria, campionessa nazionale di pattinaggio, è bellissima. Per qualche oscura ragione Nuria viene esclusa dalla sua squadra e privata della borsa di studio per lo sport, ragion per cui non potrebbe più allenarsi non essendoci una pista in città. Enric, per poter passare del tempo con la ragazza, costruisce una pista di pattinaggio nella villa abbandonata e in rovina di Benvingut dirottando i fondi del comune. La descrizione della pista e della villa sono bellissime come pure tutti i sogni che riguardano il pattinaggio. L’immagine di Enric che sogna di pattinare come Nuria e le immagini legate ai sogni sono incredibili. Anche la pista è un luogo suggestivo, quasi metafisico. E’ descritta al centro di un labirinto, ricavato nell’antico palazzo in rovina, che a sua volta è come un altro labirinto di sale, scale, stanze. La storia è tutta bellissima, con un finale perfetto, leggermente malinconico, del resto non poteva essere diversamente. Alcune immagini e alcuni passaggi sono di una bellezza eccezionale. Pure i libri nel libro sono interessanti e con immagini simboliche: il fiume ad esempio in cui pattina la santa protettrice delle pattinatrici è come una spada che separa giorno e notte. Così la pista è teatro di una storia d’ amore atemporale, che Enric vorrebbe eterna, ma sembra anche un altare dove si compie il “sacrificio umano”. Secondo me, questo è il miglior libro di Bolano.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 25 Gennaio, 2019
Opinione inserita da ornella donna 25 Gennaio, 2019
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Ferita turpe in terra di Langa
Alessandro Perissinotto, classe 1964, docente di Teorie e tecniche delle scritture all’Università di Torino, autore di numerosi libri di grande successo, ultimo dei quali Quello che l’acqua nasconde, torna sulla scena letteraria con Il silenzio della collina. Un libro che narra di:
“una ferita, nella carne viva di questi posti.”.
A quale ferita si allude? Al caso di Maria Teresa Novara, una ragazzina di tredici anni che fu rapita da due balordi, portata in una cascina, brutalmente stuprata, messa a disposizione per soddisfare le voglie malsane dei signorotti locali che pagavano i due aguzzini. E quando i due delinquenti, per uno scherzo del destino, vengono arrestati per altri reati, e uno muore affogato nel Po, lei, lasciata sola, muore di fame, freddo e di stenti. Anzi si scopre, più tardi, che muore asfissiata perché qualcuno ha bloccato i condotti di aerazione della cantina in cui era tenuta prigioniera. La violenza è antica, ed è connaturata a queste terre, a una
“terra dura, terra maledetta, ingrata, terra di malora.”
Ambiguità per la terra di Langa. Luoghi meravigliosi, panorami mozzafiato, che ad una vita più approfondita nascondono azioni turpi e nefandezze di ogni genere. Inquietante, allora, diventa “il silenzio della collina”:
“Tutto intorno c’era il silenzio delle colline; un silenzio pieno di rumori, di versi d’animali, di fruscii del vento tra i rami degli alberi e fatto di immobilità assoluta. Un silenzio insopportabile.”
Ed è proprio in questa turpe ed ambigua quiete che si svolge la storia di Domenico Boschis, nato nelle Langhe, ma ben presto trasferitosi a Torino con la sola madre, stanca delle botte ricevute dal marito. Lì iniziano una nuova vita, con un compagno differente. Dopo gli studi Domenico si trasferisce a Roma, dove svolge, con successo, la professione di attore. Ma ora suo padre, affetto da una grave malattia, lo costringe a fare i conti con una parte di vita che lui vuole dimenticare. Tutto precipita in un abisso oscuro quando Domenico, dopo che il padre gli ha urlato con le poche forze rimastagli: “La ragazza! La ragazza, Domenico!”, intraprende una personale indagine, che lo riporta all’indietro nel tempo, in un clima di omertà e di voglia di dimenticare, che lo travolgono, dannandolo per l’eternità.
Il libro è accattivante, molto curioso, feroce e assai crudo. Moltissimi i temi trattati e i riferimenti culturali, molto dotti e precisi. A cominciare dal tema, di stretta attualità, della violenza sulle donne, quel gesto malsano contro cui solo gli uomini devono porvi rimedio, perché:
“Le botte a mano aperta provocano più rumore e dolore e lasciano lividi solo nell’animo.”
Altro tema che percorre tutto il romanzo è il rapporto tra padre e figlio, analizzato nei particolari, prendendo a prestito brani de La lettera al padre di Kafka, per cui:
“Così come veritiere erano le considerazioni di Kafka sulla sincerità e la finzione. Sono un bastardo, ma sono sincero; gli altri che non lo sono fingono soltanto di non esserlo. Un assioma auto assolutorio, l’ipocrisia dei sinceri. (…) La sua prepotenza non disponeva di costrutti sintattici così elaborati e, in fondo, quei costrutti non le servivano: bastavano gli sguardi, le alzate di spalle, i silenzi.”
E poi, ovviamente, in terra di Langa: Fenoglio e la sua Malora, un accenno breve a Pavese, Torino e tant’altro. Un libro ricco,di gran fascino, che urla, pur parlando con quella signorilità e fascino che caratterizza tutti i libri di Alessandro Perissinotto. Testo inappuntabile, trama e personaggi privi di alcun difetto. Forse unico appunto: una qualche sfumatura avrebbe reso il ritratto feroce e crudo di queste terre e dei loro abitanti, un po’ più consono al reale. Più vicino all’altra faccia della medaglia che ha voluto tali terre Patrimonio dell’Unesco. Vivamente consigliata la lettura di un testo che fa riflettere con sobrietà ed eleganza di stile.
Indicazioni utili
Mona
Il romanzo d'esordio della scrittrice statunitense Jen Beagin, “Facciamo che ero morta”, è incentrato sulla figura della protagonista, Mona.
Mona è una giovane donna di venticinque anni che lavora come donna delle pulizie e fa volontariato distribuendo kit di siringhe nuove ai tossicodipendenti. Il romanzo si apre trasportandoci subito in medias res: Mona sta distribuendo kit puliti quando nota un tossico e scatta l'amore a prima vista.
«L'aveva soprannominato Mister Laido per l'aspetto e i vestiti sporchi. I capelli erano lunghi e formavano un groviglio che solo un bel trattamento all'olio caldo sarebbe riuscito a districare. La faccia era un elaborato reticolo di rughe. Ma era alto, aveva le spalle larghe e, dovendo o volendo, sarebbe stato in grado di prenderla di peso e fare il giro dell'isolato o salire una rampa di scale, cosa che non si poteva certo dire dei suoi fidanzati precedenti. Però si era innamorata soprattutto dei suoi occhi, così scuri e sinceri, che sembravano dire: “Tu sei qui”. »
Fin da subito ci rendiamo conto che Mona è un po' particolare: non solo perché ha scelto di fare la colf, pur essendo giovane e angloamericana, non solo perché si innamora di un tossico poco pulito molto più vecchio di lei che ha in programma di autodistruggersi, ma soprattutto perché è molto sola, triste, con probabili disturbi mentali che le derivano da traumi vissuti nell'infanzia.
Il romanzo apparentemente potrebbe ricordare “Eleanor Oliphant sta benissimo”, con il quale ha in effetti dei punti di contatto. Innanzi tutto perché entrambi narrano la storia di una giovane donna ferita dalla vita durante l'infanzia, che riporta in età adulta diverse turbe psicologiche. Però la somiglianza è solo apparente. Il romanzo di Gail Honeyman narra con determinazione una vicenda di ascesa: dalla solitudine all'amicizia, dal disturbo mentale alla sua guarigione, dalla tristezza alla speranza. E' evidentemente costruito per venire incontro al gusto del lettore, che si sente appagato dalle storie che evolvono in una certa direzione.
“Facciamo che ero morta” non è così. C'è il tentativo di superare il passato e giungere ad una condizione di vita migliore, che procuri minore sofferenza, infatti ad un certo punto, spinta da un evento traumatico, Mona lascia il New England e si trasferisce a Taos, in New Mexico. Il suo percorso di evoluzione rispetto al passato però non è lineare, né facilmente comprensibile. Mona è un personaggio strano e complesso, grottesco in diversi aspetti, e, nel New Mexico non farà altro che incontrare personaggi altrettanto strani, ambigui e a volte grotteschi, se pure sempre molto differenti da lei. Si tratta di un romanzo di formazione molto originale.
Lo consiglio se amate le storie un po' alternative, con personaggi e situazioni lontani dall'essere esemplari e perfetti, ma piuttosto grotteschi e bislacchi, che vogliono raccontare la difficoltà e la tristezza del vivere.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 17 Gennaio, 2019
Opinione inserita da ornella donna 17 Gennaio, 2019
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il dolore del cuore
Un cuore tuo malgrado è il romanzo d’esordio di Piero Sorrentino, nato a Napoli nel 1978. Dottore di ricerca in Studi letterari, ha pubblicato racconti in antologie, ed ora approda sul palcoscenico letterario con questa sua opera.
“Un cuore tuo malgrado” è una espressione, come afferma lo stesso autore, che compare nel romanzo Il cardellino di Donna Tartt. Ma è anche un modo con cui la moglie di Dario Spatola commenta il carattere e il modo di essere del marito. E’ il cuore di Dario viene messo a dura prova nel suo percorso di vita e sarà difficile, quasi impossibile, recuperare un po’ di cuore! Già perché una mattina Dario ha un terribile incidente in cui periscono sua moglie Giulia e il figlio Vittorio. A causare l’incidente una fatale distrazione di Bianca, guidatrice di autobus, come il suo stesso padre. Bianca, quella mattina, si fa distrarre dal suo contemplare in modo gioioso il mondo che la circonda, le sue luci, la sua bellezza, e non vede la station wagon blu di Dario. L’impatto è tragico e segna in modo indelebile sia Bianca che Dario. Bianca inizia un lungo pellegrinaggio tra fisioterapia e un dolore che non riesce ad elaborare. Scrive a Dario ed implora il suo perdono, o perlomeno la sua comprensione. Ma la reazione è tanto fredda quanto terribile:
“Si sa come va in questi casi, no? Le attenuanti generiche, la mancanza di condanne pregresse, l’impossibilità tecnica di definire se la mia condotta di guida avesse contribuito o meno all’esito disastroso dell’evento, e tutta quella disgustosa paccottiglia giuridica grazie alla quale lei s’è salvata dall’unica cos che si meritava: la galera. Sono certo, dunque, che avrà capito da sola – sempre che nel frattempo non si sia distratta un’altra volta- che non ho alcuna intenzione di incontrarla o di stare ad ascoltare le sue spiegazioni. Le auguro,cara Bianca, un’esistenza tormentosa e incerta. Come quella alla quale, con la sua superficialità e la sua incoscienza, lei ha condannato me.”
Bianca, aiutata dalla sorella Margherita, rievoca dolori anche del passato, come la morte del padre, tanto inaspettata e veloce. Le immagini del padre sono un rifugio e un tormento ad una esistenza che pare non avere più senso:
“E’ strano, ma della sua voce so ricordarmi solo se ripenso a quel pomeriggio, perché appartengo alla vasta schiera di coloro che riescono a sentirsi a loro agio unicamente nelle lontananze, a dialogare con gli assenti, a regalare amore nei ricordi.”
Sarà un faticoso allenamento al dolore il cammino futuro della sua vita, tra autodistruzione e forza immane di volontà, alla ricerca di un equilibrio.
Un romanzo dalla trama e dai contenuti veramente belli e notevoli. Una prosa schietta e profondamente scarna lo caratterizzano. I capitoli molto brevi, circa due o tre pagine, rendono la lettura veloce e molto colta. Personalmente mi rende perplessa proprio questa caratterizzazione. I personaggi sono poco descritti, anche nei loro tratti distintivi. Nullo è lo scavo introspettivo e psicologico che, invece, la situazione descritta richiede. Un maggiore approfondimento di questi aspetti avrebbe reso la lettura di questo libro maggiormente piacevole. Pur nella insita piacevolezza della trama.
Indicazioni utili
- sì
- no
Florent-Claude Labrouste
«Ero capace di essere felice nella solitudine? Pensavo di no. Ero capace di essere felice in generale? È il tipo di domanda che credo sia meglio non farsi» p. 81
Florent-Claude Labrouste ha quarantasei anni, è funzionario del ministero dell’Agricoltura con un conto in banca superiore a settecentomila Euro, abita con Yuzu, donna di origine giapponese poco più che ventenne – particolarmente libertina, sessualmente disincantata e propensa alle sperimentazioni con soggetti diversi dal suo partner – con cui ha una relazione da circa due lustri ormai giunta al suo termine, in un appartamento extralusso alla periferia di Parigi e odia il suo nome perché gli elementi che lo compongono sono del tutto sbagliati. Florent è troppo dolce e vicino al femminile Florence, in senso quasi androgino, Claude rimanda alle Claudettes e al video vintage di Claude Francois ripassato a ripetizione in una serata omosessuale. A causa di una depressione, misantropia e senso di insoddisfazione sempre più pressanti decide di abbandonare la sua vita e di far perdere ogni traccia di sé. Gli sembra, d’altra parte, l’unica alternativa valida all’altra possibilità per riacquistare la libertà, e consistente cioè, nell’omicidio di quella compagna la cui presenza è divenuta insopportabile. Per garantire la riuscita della sua fuga e per tenere sotto controllo questo profondo stato di inquietudine è però necessario un “aiutino” esterno, decide così – a partire dal 2017 – di usufruire della ricerca scientifica e di iniziare a prendere un farmaco di ultima generazione chiamato Capton D-L o più semplicemente Captorix. Quest’ultimo non è altro che una piccola compressa bianca, ovale e divisibile che si basa sull’aumento della secrezione di serotonina nel sangue inibendone la ricaptazione da parte dei neuroni 5-HT1 e che con un “piccolo sacrificio” garantisce i risultati sperati.
«Per questo merito la morte, e anche punizioni ben più gravi, non posso nascondermelo: finirò la mia vita infelice, bisbetico e solo, e me lo sarò meritato.»
Il fuggifuggi porta questo eclettico personaggio in Normandia dove, se da un lato il flusso di pensieri si concentra sulle precedenti relazioni e sulla ricerca un amore perduto, dall’altro, lo porta a rincontrare Aymeric, vecchio amico allevatore di mucche di antica stirpe nobiliare, lasciato dalla moglie, separato anche dalle figlie su cui vanta un diritto mai esplicato di affidamento e che affronta un periodo di crisi economica a causa del crollo delle quote del latte. Sarà durante questa visita che emergerà uno degli episodi più brutali e di forte impatto del volume, un episodio che richiamerà proprio gli scontri dei gilet gialli e che non mancherà di ricollocare l’ottavo lavoro di Houellebecq nella realtà più attuale e più precisamente nelle distorsioni e storture di un presente collocato nell’attesa di un prossimo – e remoto – futuro affatto più propositivo.
«In Occidente nessuno sarà più felice, pensava ancora, mai più, oggi dobbiamo considerare la felicità come un’antica chimera, non se ne sono più presentate le condizioni storiche»
Mediante l’ausilio di una voce narrante armata da una scrittura densa, fluida eppure tormentata e stratificata da una composizione strutturata in lunghi periodi che si tramutano in coscienza pura e auto-analisi, “Serotonina” è una vera e propria confessione di sofferenza, rancore, ossessione che si articola in un alternarsi continuo tra un presente e un passato che nulla risparmia al conoscitore. Alcuni passaggi, in particolare, sono spinti – come consueto dal saggista – ai massimi livelli tanto da disturbare con la loro crudezza, eccessività (anche sessuale). A questi se ne aggiungono altrettanti ironici e arguti che celano profonde riflessioni.
Il risultato è un elaborato controverso, che infastidisce, che sa essere particolarmente crudele e spietato, che non teme di mostrare le conseguenze peggiori e più estreme di quella società fatta di competizione, fretta, ritmi serrati, freneticità, che non ammette pause, che non consente alternative, che non offre seconde possibilità, possibilità di riscatto o rivalsa e dove la forbice tra ricco e povero è sempre maggiore.
Non stupisce quindi che l’opera di Michel Houellebecq sia stata una delle più attese e promettenti del 2019, non stupisce che abbia raggiunto un immediato successo di vendita in madrepatria, non stupisce che sia considerato il capolavoro di questo autore. Se deciderete di leggerlo ricordate che “Serotonina” non ha limiti e non vuole averne. È una corrente ininterrotta, una cascata di pensieri in costante accelerazione e mai in decelerazione, un torrente che non teme di far storcere il naso e creare disappunto in chi legge, che non teme il suo essere intrinsecamente provocatorio, che non teme di mettere a nudo le anime moderne, che tratta tematiche varie che vanno dal sesso, alle perversioni sessuali, alle crisi esistenziali, all’amore, alla rappresentazione della Francia e dell’Europa del nuovo millennio, che osa. Perché “Serotonina” nel suo toccare una totalità inarrestabile di problematiche e questioni non è altro che un romanzo fortemente umano che per questo si fa amare e odiare. Può inoltre stordire per la prolissità con cui è costruito. La sensazione, grazie alle varie digressioni, ai ragionamenti e pensieri che si susseguono, è quella di essere letteralmente all’interno della mente di Florent, cosa che rende il protagonista vivido e concreto ma che al contempo può rallentare la lettura.
«È una piccola compressa bianca, ovale, divisibile. Non crea né trasforma. Ciò che era definitivo, lo rende passeggero; ciò che era ineluttabile, lo rende contingente. Fornisce una nuova interpretazione della vita – meno ricca, più artificiale, e meno improntata a una certa rigidità. Non dà alcuna forma di felicità, e neppure di vero sollievo, la sua azione è di tipo diverso: trasformando la vita in una serie di formalità, permette di raggirare. Pertanto aiuta gli uomini a vivere, o almeno a non morire – per qualche tempo. La morte, tuttavia, finisce per imporsi, l’armatura molecolare si incrina, il processo di disfacimento riprende il suo corso. È sicuramente più rapido per quelli che non hanno mai fatto parte del mondo, non hanno mai ipotizzato di vivere, né di amare, né di essere amati; quelli che hanno sempre saputo che la vita non era alla loro portata. Costoro, e sono tanti, non hanno niente da rimpiangere, come si è detto; io non rientro nella categoria. Avrei potuto rendere felice una donna. Anzi, due: ho già detto quali. Tutto era chiaro, estremamente chiaro, sin dall’inizio; ma non ne abbiamo tenuto conto. Abbiamo forse ceduto a illusioni di libertà individuale, di vita aperta, di infinità dei possibili? È probabile, quelle idee erano nello spirito del tempo; on le abbiamo formalizzate, ce ne mancava l’inclinazione; ci siamo limitati a conformarci a esse, a lasciarcene distruggere; e poi, per molto tempo, a soffrirne.» p. 331-332
Indicazioni utili
Poveri cristi
È un’America anonima e spenta, pullulante di grigie periferie e poveri cristi in balia di solitudine e tossicodipendenza, quella che trova spazio, e voce, nelle pagine di “Jesus’ son” dello scrittore statunitense Denis Johnson, scomparso nel 2017 e considerato negli USA tra i maggiori autori di racconti del nostro tempo.
Non a caso, questo libro, pubblicato da Einaudi sul finire dello scorso mese di novembre, si presenta come una raccolta di singoli racconti accomunati però da quello che ha tutta l’aria di essere il medesimo io narrante, protagonista di una vicenda i cui tasselli sono episodi talvolta tragici e amari, talaltra quasi surreali.
“Stavo all’Holiday Inn da tre giorni, sotto falso nome, in compagnia della mia ragazza, sinceramente la donna più bella che avessi mai conosciuto, a farmi di eroina. Facevamo l’amore a letto, mangiavamo bistecche al ristorante, ci bucavamo al cesso, vomitavamo, piangevamo, ci accusavamo, ci imploravamo, ci perdonavamo, promettevamo e ci portavamo in paradiso a vicenda.” (da “Lavoro”)
Si rimane colpiti sia dal contenuto dei testi sia dallo stile narrativo dell’autore, e non sempre positivamente; in un primo momento, forse, addirittura spiazzati e spaesati. Per quanto mi riguarda, pur essendo un’appassionata di racconti e convinta sostenitrice del loro grande valore letterario spesso oggi snobbato da numerosi lettori, questi di Johnson non rientrano propriamente nel genere che preferisco e si discostano, solo per fare un esempio, da quelli di Nickolas Butler, altro noto autore americano contemporaneo, di cui, nei mesi scorsi, avevo letto e molto apprezzato la raccolta “Sotto il falò” (Marsilio, 2018).
Tuttavia, ho trovato almeno due racconti (“Matrimonio sporco”, dove si parla d’aborto, e “Beverly Home”), nonché diversi passi sparsi tra gli altri titoli presenti in “Jesus’ son”, di una profondità sorprendentemente disarmante che, d’un colpo, mi ha fatto rivalutare l’intera opera. Il senso della solitudine che sfocia nell’emarginazione, il peso dell’esistenza che cerca leggerezza nello sballo artificiale e nel sesso, la sofferenza di mucchi di umanità allo sbando emergono attraverso una scrittura che a tratti, per una inaspettata liricità, incanta. E fa molto riflettere.
“Sono salito su una carrozza mentre si chiudevano le porte; come se il treno stesse aspettando proprio me. E se ci fosse solo neve? Neve dappertutto, fredda e bianca, a riempire ogni distanza? E io che attraverso questo inverno seguendo il mio senso delle cose, finché non raggiungo un boschetto di alberi bianchi. E lei mi fa entrare.
Uno stridio di ruote, e d’un tratto ho visto solo le scarpe grosse e brutte degli altri passeggeri. Il rumore è cessato. Abbiamo oltrepassato scene di una solitudine straziante.
Attraverso i quartieri e oltre i marciapiedi delle stazioni, ho sentito la vita cancellata che mi sognava alle spalle. Sì, un fantasma. Una traccia. Qualcosa che rimane.”
Una lettura che, con buona probabilità, potrebbe non andare incontro ai gusti di tutti i lettori, ma non da rigettare in toto. Di certo, un autore da approfondire.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
‘O conto quaicuno ‘o tè da pagà
Agora “con l’accento sulla prima a, per piacere, quella iniziale” è un paese (immaginario) arroccato alle pendici dei monti Lepini. Metà sta in pianura e metà con le spalle ai colli. È situato tra Norma, Sermoneta e Sezze, s’affaccia sulla piana dell’Agro Pontino e, quando c’è bel tempo, da lì si vede sino al mare di Ostia antica. Conta meno di ottomila abitanti, tutti si conoscono, o quasi. Tra le strette stradine di Agora, in quei luoghi ove ancora si mostrano tracce dell’antico fasto della Roma dei Cesari, non accade mai nulla, o quasi. Là, la vita scorre uguale. Sempre. O quasi. Perché il 25 febbraio 1996 accadde un fattaccio inaudito: due giovani, due fidanzatini, furono ritrovati uccisi in un modo brutale, animalesco. Emanuele Ferraro, 23 anni, disoccupato, ricevette 60 coltellate. Loredana Proietti, 17 anni, studentessa, 124, in tutte le parti del corpo. Sino a sfregiarla. A ritrovarli furono il padre di lei, ex carabiniere in pensione, assieme al figlio minore Michele e ad un amico di Emanuele, Giacinto Sangiovanni. Preoccupati per la irreperibilità dei due, penetrarono da una finestra della casa di Emanuele sfondando un vetro ed trovarono la ragazza in un mare di sangue sul letto. Emanuele era nel bagno, semi accasciato sul lavandino.
Questa è la storia dell’indagine e del successivo processo che ha portato alla condanna del presunto omicida o, forse, dell’oscuro errore giudiziario che ha sbattuto in galera un innocente incastrato da indizi inconsistenti e argomentazioni giudiziarie fragilissime, quando non speciose. Rileggendo i verbali di interrogatorio, riascoltando i testimoni (tra essi anche gli autori del fatto?), consultandosi con esperti esterni, compulsando documenti storici, il libro cerca di ricostruire i fatti (inventati, ma profondamente ispirati ad un fatto vero) e di fare una analisi storica, sociologica e psicologica dell’episodio e del suo contesto culturale. Si inoltra nel labirinto di deposizioni contraddittorie e contrastanti. Cerca di individuare indizi o elementi di prova accusatoria o a favore. Ci riferisce l’epilogo (insoddisfacente) della vicenda giudiziaria e ci suggerisce una seducente spiegazione alternativa. Scopriremo così che nessuno è esente da colpa, piccola o pure grande. Che anche i fidanzatini non erano angeli scesi in terra. Che i loro amici e parenti avevano, ognuno, punti d’ombra più o meno oscura. Ma scopriremo, pure, che su nessuno di essi si è formata la prova inconfutabile della responsabilità per un così atroce delitto.
L’unica cosa che verrà provata, alla fine, l’unica cosa che emergerà, indiscussa, è la constatazione che il reale è inconoscibile. Tuttavia, come si sarebbe commentato ad Agora: “’A justizzia è justizzia però e ‘o conto quaicuno ‘o tè da pagà” (La giustizia è giustizia e qualcuno deve pagare il fio) quindi qualcuno sconterà la pena anche se non sarà colui che la merita.
Il libro di Pennacchi è davvero strano e si presta a molteplici modalità di lettura e, di conseguenza, ad altrettanto numerose chiavi interpretative. Io, e ammetto il mio errore, ho preteso di leggerlo come un romanzo, nonostante lo stesso autore avverta sin dalle prime pagine di non essere capace di scrivere un romanzo giallo. Anzi egli stesso esordisce proprio scrivendo “Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima intenzione di impicciarmi di questa storia”, mentre più sotto soggiunge “a ognuno il suo mestiere. E il giallista non è il mio”.
Io lettore, per tutte le prime cento pagine, ho pensato che, forse, se avesse seguito quel suo istinto iniziale avrebbe compiuto un’opera meritoria. Infatti, la prima parte del romanzo non è altro che la trascrizione, mi auguro non pedissequa, ma ampiamente rielaborata (perché sennò altrimenti…) dei verbali dell’inchiesta. L’asciutta, scarna e ostica prosa di Carabinieri, Polizia di Stato, Procuratore della Repubblica, Giudice del riesame è solo saltuariamente interpolata dalle divagazioni storico-sociologiche dell’A.; dal racconto di episodi autobiografici; dai commenti che, lui, da spettatore esterno, si sente di aggiungere alle risultanze istruttorie. Ne risulta un testo difficilmente leggibile, faticoso, assai poco accattivante. Poi, la narrazione si fa più fluida. La prosa diventa più facile da seguire e più piacevole, quando, dal riferire l’indagine, si passa alla sua analisi, alla formulazione delle ipotesi, all’indagine su moventi, credibilità di alibi e deposizioni, plausibilità degli atti d’accusa. Ma complessivamente non è un’opera soddisfacente, come romanzo, pur avendo sezioni interessanti e pagine anche molto gradevoli.
Ma ripeto, il mio approccio s’è rivelato sbagliato. A posteriori mi son reso conto che avrei potuto seguire l’indagine non solo leggendola, ma letteralmente studiandone le deposizioni; confrontandole le une con le altre, mettendo in evidenza le contraddizioni e le lacune; ricostruendo le storie secondo le singole versioni dei fatti. Se avessi avuto la pazienza di seguire questo metodo di lettura — che mi avrebbe sicuramente impegnato un tempo almeno triplo — avrei goduto delle seducenti esperienze dell’inquirente, avrei individuato la caterva di incongruenze su cui si basò quell’inchiesta, che sono assai di più di quelle evidenziate dall’A., e, forse, con un’analisi approfondita, avrei pure scoperto il vero colpevole dove Tribunale, Corte d’appello e Cassazione hanno fallito. Insomma, avrei “giocato” assieme all’A. a fare il detective.
In alternativa, ponendo sullo sfondo il filone narrativo principale, e concentrandosi unicamente sulle interpolazioni fatte scivolare da Pennacchi tra gli atti di causa, avrei tratto piacere dagli aneddoti storici e dalle dotte citazioni a supporto, dalle digressioni psicologiche e da quelle sociologiche, spesso molto profonde, dai gustosi i battibecchi tra l’A. e lo Psicanalista o l’eminente Penalista scelti come consulenti. Pure gli intermezzi autobiografici avrebbero accresciuto il loro godimento.
Purtroppo così non è stato, e me ne rammarico. Pur riconoscendo all’A. un’ottima tecnica narrativa, una non comune abilità a miscelare i vari stili riuscendo a passare dall’uno all’altro in punta di piedi, in modo quasi inavvertibile, non posso onestamente annoverare questo libro tra le mie preferenze. Solo alla fine ho deciso di aggiungere una stellina alla piacevolezza, e proprio per scusarmi per il mio errato approccio al libro al quale debbo riconoscere il merito di aver tramutato un fattaccio di cronaca in un’opera letteraria non priva di pregio.
Perciò, pur non sentendomi di sconsigliarne la lettura, debbo avvertire che si tratta di qualcosa molto più impegnativa di quanto le 214 pagine di testo farebbero supporre.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La terra del cervo
“Le persone affette da demenza da lunghi anni, che sembrano aver rinunciato al mondo e a cui il mondo sembra avere rinunciato, verso la fine della loro vita hanno una specie di risveglio e riprendono lucidità, come se la demenza fosse solo una finzione, un gioco, o magari un modo di difendersi dagli altri. E quando la morte si avvicina la maschera cade e lascia spazio al dolore, alla sofferenza e forse al rimorso. Così anche se per anni sono sembrati indifferenti a chi si è preso cura di loro, in punto di morte sembrano aggrapparsi a quelle persone e avere bisogno di un loro sguardo, di una carezza.”
È Zvi Luria, ex ingegnere ai lavori pubblici, responsabile di grandi opere come costruzioni di strade e tunnel destinati a congiungere luoghi altrimenti irraggiungibili, il protagonista dell’ultimo romanzo di Abraham Yehoshua ed è intorno al suo decadimento cognitivo che l’autore costruisce una storia che offre molteplici e importanti spunti di riflessione.
È dunque proprio quando Zvi, raggiunti i limiti di età, deve abbandonare il lavoro e rinunciare alla costruzione di altri tunnel sull’autostrada, che egli si trova prigioniero del tunnel più buio dell’esistenza. La sua progressiva perdita di identità si accompagna a una inevitabile perdita di dignità umana e sociale, tanto più rilevante quanto più prestigioso è stato il ruolo ricoperto nel passato. Ed è proprio il tema dell’identità che è centrale nel romanzo.
Se Zvi, il cui nome evoca l’immagine maestosa del cervo, va progressivamente verso una perdita di prestigio e di consapevolezza di sé, altrettanto privi di identità, per motivi politici, sono i pochi rifugiati palestinesi nascosti in cima a una collina nel deserto del Negev. È per salvare l’esistenza di costoro che Zvi è chiamato a raccogliere le sue ultime capacità cognitive, necessarie a costruire il tunnel che impedirà la demolizione della collina, altrimenti indispensabile per la realizzazione della strada che servirà all’esercito. Il tunnel assume qui, ancora una volta, una valenza positiva, in quanto rifugio e via di salvezza.
Il tema della convivenza con i palestinesi è d’altronde presente in tutto il romanzo: Yehoshua non manca di sottolineare come in molti casi essi siano riusciti ad integrarsi nella società israeliana e come i bambini palestinesi siano curati negli ospedali israeliani. Si nota, tuttavia, quanto egli sia sensibile al problema della perdita di identità nazionale che l’integrazione stessa può comportare. Non a caso il personaggio Zvi insiste a chiamare la bella Ayalà con il suo nome originale Hanadi, quasi a voler sottolineare l’importanza e il diritto/dovere di rispettare le origini di ciascun individuo. A questo proposito ricordiamo che Yehoshua , con Oz e Grossman ha sottoscritto il documento favorevole al riconoscimento dello stato della Palestina.
Proprio spinto da questo desiderio di pacifica convivenza, Zvi con un ultimo sforzo volto a controllare il suo stato confusionale, affronta un avventuroso viaggio per raggiungere di nuovo il deserto di Negev, luogo simbolo nella storia di Israele, dove riposano le spoglie di Ben Gurion, al fine di constatare che i lavori del tunnel siano iniziati e soprattutto che i rifugiati siano in salvo. Ed è qui che Zvi si ricongiunge al cervo, al suo alter ego, la cui sagoma si staglia maestosa sulla collina. Ed è qui che simbolicamente finirà il suo viaggio, lasciando al lettore un amaro e doloroso interrogativo sul futuro.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
castore e polluce
La prima cosa che mi ha incuriosito leggendo questo libro è l’autore. Una coppia sposata che si dedica a questo genere, infatti mi intriga parecchio. Soprattutto perché raramente ho letto qualcosa di così crudele e inquietante. Mi sono spesso soffermata a immaginarmi la vita di coppia di questi due signori scandinavi: colazione parlando di cadaveri, pranzo con un accenno al modo più doloroso per uccidere qualcuno. Comunque la parte più interessante del romanzo, così come deve essere, rimane la trama e non i suoi autori. Io non avevo letto in precedenza niente di Lara kepler, quindi non ero a conoscenza delle vicende di Joona Linna e della sua squadra. Non ho comunque trovato alcuna difficoltà a destreggiarmi tra le varie vicissitudini dei protagonisti e a capire per sommi capi cosa è successo nel passato. In questo episodio si verificano in tutta Europa una serie di delitti particolarmente cruenti, che hanno come vittime dei delinquenti abituali. Le polizie dei vari stati se ne preoccupano relativamente liquidando la cosa come un beneficio per la società. Se ne preoccupa, invece Linna che intuisce che dietro potrebbe esserci la mano di Jurek Walter. Si tratta di una vecchia conoscenza del poliziotto che ha ucciso anche la compagna di Linna, oltre ad aver braccato lo stesso e sua figlia per parecchi anni. Peccato che Jurek è stato ucciso da Saga Bauer, il suo corpo finito in acqua è stato ripescato e il DNA ha confermato che si trattava di lui. E allora Linna è solo vittima delle sue ossessioni, o il suo sesto senso ha ragione e il serial killer è riemerso dalla tomba? A questo punto inizia ha un lato una fuga nel tentativo di salvare sé e i propri cari da parte di chi crede alla seconda ipotesi. Gli altri e sono la maggior parte, invece indagano in altre direzioni. La decisione di dividersi si rivela il primo grande errore dei “buoni”.
Questo libro mette in discussione molte regole del giallo. Intanto il serial killer in oggetto non è crudele: è efficiente. Questo lo rende del tutto amorale, insensibile verso la sofferenza delle vittime. Ciò che conta è l’obiettivo da raggiungere. Poi è molto intelligente e sempre razionale. Tutte le sue mosse sono ben calcolate e calibrate in modo da ottenere il massimo danno col minimo dispendio di energia. Spesso sono le stesse vittime che abilmente guidate da lui si fanno più male di quanto avrebbero immaginato di potersi fare. Di conseguenza anche chi lo insegue deve diventare come lui. Questa caccia non è adatta a uomini e donne con un buon cuore. Nessuna pietà neppure di fronte a qualcuno che implora di fermarsi, perché in questo caso chi à pietoso ha perso in partenza.
Inutile sottolineare che mi è piaciuto molto questo romanzo. Trama ricca di personaggi e di ambientazioni, ma sempre precisa e mi ripetitiva o banale. Stile semplice da seguire, ma con molti dettagli, a volte anche raccapriccianti, comunque sempre funzionali alla trama e non inseriti solo per il piacere di scuotere il lettore. Finale che è riuscito a sorprendermi, senza buonismi, e senza lieto fine.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 07 Dicembre, 2018
Opinione inserita da ornella donna 07 Dicembre, 2018
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Colomba, Dante e il Padre: ultima puntata
Sandrone Dazieri, dopo aver pubblicato Uccidi il padre, a cui ha fatto seguito L’angelo, torna in libreria con Il re di denari. Protagonisti assoluti di questa trilogia sono Colomba Caselli e Dante Torre.
Colomba è una poliziotta, che dall’ultima indagine ha riportato una grave ferita all’addome, conosciuta come “la combattente di Venezia”, si è ritirata a vivere tra le colline delle Marche, ovvero:
“Aveva trentacinque anni, ed era un vicequestore aggiunto della polizia, a riposo da quando un fantasma le aveva infilato un coltello nell’addome e rapito Dante Torre, l’Uomo del Silo.”
Ora è disorientata, ferita nel corpo e nell’anima, è:
“Ancora magra e pallida, coperta con una finta pelliccia che sarebbe stata bene addosso a un homeless, con gli occhi lucidi e cerchiati.”
Piange la scomparsa nel nulla di Dante Torre, forse il suo unico amico, geniale ed estroso cacciatore di persone scomparse. Chi è? Lui ha alle spalle una particolare storia di sofferenze e di abusi, inflittagli dal Padre:
“Dante non ricordava nulla del proprio passato, quello che sapeva della sua famiglia era stato un falso ricordo inculcatogli dal Padre durante i lunghi anni di isolamento della sua infanzia. “
Ma chi è questo famigerato Padre?
“Il Padre aveva agito in due periodi distinti. Il primo era stato tra la fine degli anni Sessanta fino al 1989. Le vittime del primo periodo, le otto identificate, sembravano pescate in modo casuale nella mappa d’Italia. Un bambino era stato rapito durante una gita scolastica vicino Roma, un altro fingendo annegamento tra i mulinelli del Po in Emilia. L’unica cosa che avevano in comune era l’essere stati seppelliti tutti assieme in barili di acido un giorno imprecisato dell’89. La documentazione della seconda fase, cominciata negli anni Duemila, era corposa quanto la prima e riguardava anche lei e Dante. (…) Tutti i prigionieri erano stati identificati, ma non tutti erano tornati con le rispettive famiglie. Alcuni di loro erano scomparsi da anni ed era stata dichiarata la loro morte presunta, i genitori si erano separati o erano morti, o non avevano voglia di riprendere a occuparsi di figli problematici, diventanti ancor più problematici durante la prigionia.”
Ora Colomba è sola, in un villino di campagna sommerso dalla neve, isolata e al freddo, quando da alcuni rumori esterni si accorge che c’è un ragazzino nella rimessa. E’ impaurito, sporco di sangue e non parla. Si accorge subito che lui è autistico, per di più ha gli stessi riflessioni incondizionati che erano caratteristiche tipiche dei bambini abusati dal Padre. Schiena rivolta all’interlocutore, uno strano e continuo dondolio rivolto alla finestra. Lo carica sull’auto e si reca dai Carabinieri della locale stazione. Scopre che lui si chiama Tommy, e la sua famiglia adottiva è stata barbaramente trucidata. I sospetti si concentrano immediatamente su di lui. Ma Tommy è, in realtà, il centro di un mistero che affonda le radici in un altro passato, che lo collega direttamente con la scomparsa di Dante. Così quando la stessa riceve una telefonata in cui le si consiglia di:
“una lunga vita tra le colline”,
non può che agire, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. E forse anche quella dello stesso Dante.
Sandrone Dazieri in quest’ultimo capitolo della trilogia, costruisce:
“un castello di specchi e di inganni, una matrioska di colpi di scena che si susseguono pagina dopo pagina fino all’inquietante finale.”
Una lettura ad alto tasso adrenalinico, ricco di suspence e di intrigo. Purtroppo è una lettura che rimanda fortemente agli altri due libri precedenti e ho fatto un po’ di fatica nella comprensione, non avendoli letti, ma i riferimenti sono, comunque, ben spiegati e chiari. Un thriller scritto con una prosa che avvince il lettore in una spirale densa e profonda, tra continui rimandi tra passato e presente. Inquietante ed angosciante, tratta, con passione e perizia di metodo, molti importanti temi, quali l’autismo, la storia dei bambini abusati a Villa Azzurra a Torino, la vicenda degli autisti a Silicon Valley… Un bel libro, un po’ lungo, ma nel complesso un testo avvincente e curioso per gli amanti del genere.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Vergogna sociale
Nel 1952 Annie Ernaux ha 12 anni...ed assiste a quella che sarà per lei una scena indelebile, indicibile, che le "farà prendere sciagura" e che segnerà la fine della sua infanzia, nonché la presa di coscienza del suo status sociale.
In un pomeriggio domenicale di metà Giugno, suo padre, in preda ad un attacco di rabbia violenta, tenta di uccidere sua madre.
"Non è successo niente" le diranno poi...
Ma lei non riesce a dimenticare, non riesce a raccontare, non riesce neanche a scrivere (fino alla stesura di questo libro nel 1995) quello che ha visto.
Dal quel momento in poi sentirà su di sé il peso della vergogna, intesa proprio come "vergogna sociale", come un marchio che le entra sottopelle e che la relegherà per sempre al di fuori del ceto borghese a cui lei tanto aspirava.
Inizierà proprio in quel momento il lento rifiuto delle sue umili origini, che la porterà a "tradire" la sua essenza, i suoi genitori, la loro cultura, il loro essere così ben radicati in quel "qui da noi", con la loro latrina in cortile, la volgarità di suo padre, la camicia da notte macchiata d'urina di sua madre, come a sottolineare una precisa linea di demarcazione tra ciò che sono e ciò che non saranno mai.
La vergogna di vivere secondo regole bigotte e perbeniste, dove "nulla si pensa e tutto si compie" come è giusto che sia, rispettando i tempi prestabiliti per ogni cosa: fare la comunione, fare la permanente, avere il ciclo, le calze da donna, bere vino, fumare una sigaretta, lavorare, frequentare qualcuno, sposarsi, avere figli, vestirsi di nero, smettere di lavorare, morire.
Essere persone a modo.
Pregare.
Sapersi comportare.
Pregare.
Essere come tutti.
Pregare.
Non credersi chissà chi.
Pregare.
Ma soprattutto, fondamentale, porsi sempre la domanda "cosa penseranno di noi"?...ed agire di conseguenza.
In un ambiente così chiuso, regolato e giudicato sulla base di certi codici, non c'era assolutamente spazio per la scena di quella domenica di Giugno.
Annie sente di non poter più appartenere alla categoria delle persone perbene,
i suoi occhi hanno visto ciò che non dovevano vedere...
Come sempre, nel suo stile unico, lucido e preciso, la Ernaux cerca di scrivere, senza vergogna, un libro sulla vergogna...unico punto di congiunzione tra la donna che scrive queste pagine e la dodicenne che le ha vissute...e senza il quale, forse, non sarebbe mai nato in lei il desiderio di ribellarsi al suo ambiente, il desiderio di essere migliore, il desiderio di scrivere.
Ancora una volta la Ernaux ci dona una parte di sé, una parte importante, la scintilla che ha acceso la fiamma della sua personalissima rivoluzione e che l'ha resa la donna che è adesso, una scrittrice di grande talento che fa ancora i conti col suo passato.
Indicazioni utili
Quando la trama è uno spoiler
Quando il grande nome ti delude, è una sensazione piuttosto strana. Ti chiedi se magari è il genere d’appartenenza a non essere nelle tue corde; se il modo di scrivere dell’autore non ti entusiasma né ti emoziona; se semplicemente la storia non fa per te. John Grisham mi ha deluso con questo suo romanzo e, per quanto mi è possibile, cercherò di sviscerare i motivi.
“La resa dei conti” racconta la storia di Pete Banning, eroe di guerra che un bel giorno si sveglia e decide di uccidere il pastore della chiesa del suo paese.
Una decisione inevitabile, da quanto dice lui. Manderà in malora la sua vita, quella di sua moglie, dei suoi figli e delle persone che lavorano per lui, ma a quanto pare non c’è alternativa. Dunque lo farà e, in quanto ai suoi motivi, li porterà con sé nella tomba.
In tre righe vi ho spoilerato mezzo libro. Non mi linciate, non è colpa mia: basta che leggiate la trama e vi ritroverete nella stessa condizione. Assurdo ma vero, e nonostante questo non è nemmeno la prima volta che capita; ora non saprei dirvi quale sia stata l’altra occasione, ma questo la dice lunga su quanto il tal libro mi sia rimasto impresso. Ci si aspetta che gli eventi anticipati nella trama occupino (voglio esagerare) 50-60 pagine, che vengano appena accennati.
Invece no.
Dunque, le prime duecento pagine raccontano il processo di Pete Banning, del quale già conosciamo l’esito. Come ammazzare la suspense.
La seconda parte ci racconta le vicissitudini e gli orrori che hanno portato il protagonista a essere l’uomo che è e a diventare un eroe di guerra: forse la parte più interessante, che racconta dell’entrata in guerra dell’America e di uno scenario particolare, sempre tenuto in secondo piano quando si parla della Seconda Guerra Mondiale: la campagna delle Filippine. Pur essendo a volte ripetitivo e dilungandosi un po’, questa parte risulta interessante nonostante l’autore ci abbia permesso di sapere in anticipo che Pete Banning si salverà. In fondo, abbiamo già assistito alla sua esecuzione dopo il processo.
La terza e ultima parte si concentra sulla causa legale che porta la moglie dell’assassinato a cercare di ottenere i terreni dei Banning. A questo punto l’unica cosa che tiene in piedi la curiosità è la voglia di conoscere il mistero (l’unico) che il protagonista non ci vuole svelare e si porterà nella tomba: perché l’ha fatto? Durante la lettura speri non sia quello più banale… il primo che verrebbe in mente alla maggior parte dei lettori. Speri vivamente che l’autore si sia inventato qualcosa di eclatante, in modo da capovolgere l’opinione di un libro che è nato male.
Invece no.
Tornando alla faccenda della trama che anticipa troppo gli eventi, mi ha lasciato talmente esterrefatto che sono andato a controllare se anche nell’edizione inglese veniva anticipato l’esito del primo processo. A quanto pare… no. Mondadori, ma un po’ di furbizia? Il mio giudizio sarebbe stato sicuramente meno duro, e aver appurato il fatto che l’errore è da imputare a una scelta scellerata da parte della casa editrice italiana, ha attutito un po’ la delusione nei confronti dell’autore. Anche se nella seconda parte già sappiamo che il protagonista si salva, permetti che nelle prime duecento pagine non so se verrà giustiziato?
In conclusione, forse quello del thriller legale non sarà il genere che prediligo, ma oggettivamente c’è stata più di una scelta sbagliata. Sia da parte dell’editore che dell’autore.
“Non ho niente da dire.”
Indicazioni utili
La balena del colore della luna
Più che una favola mi è sembrato di leggere una delicatissima poesia.
Questo racconto breve di Sepulveda parla della grande balena bianca, il capodoglio color della luna. Il capodoglio racconta la vita nel profondo del mare, racconta delle altre creature che vi abitano, della vita che scorre con un equilibrio esatto e pacifico. Racconta degli usi che le balene e le altre specie hanno per coesistere tutti insieme nella grande distesa blu. Racconta delle storie che i capodogli bianchi si sono tramandati nel tempo, fino a giungere a lui, che ora ha il compito di proteggere questo equilibrio. Un equilibrio raggiunto anche con i lafkenche, gli uomini del mare, che abitano l'isola Mocha e convivono con il mare, lo venerano e lo rispettano.
Ma poi una specie diversa inizia ad arrischiarsi in mare, prima su assi di legno, poi su vere e proprie navi. Avidi e carichi di odio, sono gli uomini: l'unica specie che si attacca a vicenda. Solcano il mare, sempre più a largo, a caccia delle balene e dell'oro grasso. Arpionano e torturano e squartano senza pietà.
Il grande capodoglio si avvicina piano per conoscerli, per capirli, per imparare da loro. Quando impara che tutto quell'odio non ha fondo, quando le grandi navi degli uomini solcano il mare sempre più numerose e sempre più agguerrite, il capodoglio capisce che deve agire.
Lui ha il compito di proteggere il viaggio delle 4 vecchie balene che trasportano i corpi dei lafkenche morti sull'Isola in cui riposeranno in eterno, e quando anche l'ultimo lafkenche sarà morto e la sua anima trasportata sull'isola, allora tutte le creature del mare potranno compiere l'ultima grande traversata, guidati dagli uomini del mare, fino all'isola dove l'equilibrio del mare è ancora intatto e la furia degli uomini non potrà mai raggiungerli.
Ma una sera di tempesta la Essex, una poderosa baleniera, attacca le 4 vecchie e le uccide. Mocha Dick, cieco dalla furia, distrugge la nave e specie sul fondo del mare tutti gli uomini a bordo, consacrando la sua leggenda. Ma il compito è fallito, non si può proteggere il mare dall'uomo.
La leggenda della Essex ha dato vita a Moby Dick.
L'inizio del racconto - una balena bianca riversa a riva, morta - allla Storia di una Balena bianca raccontata da lei stessa.
Parlo di poesia, perché lo stile è tanto delicato e "leggero" da sembrare appunto poesia. Il racconto scorre come il mare, lieve, senza opinioni di sorta o giudizi. E' una storia: una storia di pace interrotta dall'avidità di una specie che distrugge e uccide chi vive in questo mondo da molto prima di lui.
Non vi è morale, giudizio o recriminazione nelle parole di Sepulveda, solo i fatti, raccontati con un carico di malinconia dolcissima. Una storia che sembra venire da lontano, che riprende i fili delle antiche tradizioni e leggende degli uomini del mare, del rispetto per un passato indigeno e profondo che affonda le radici nell'acqua salata.
Un punto di vista diverso, che per la sua leggerezza ben si adatta anche alla lettura dei più piccoli, secondo me. Anche se è ai grandi che dovrebbe far scendere una lacrimuccia, se non di pena almeno di colpevolezza.
Bellissima favola, da tenere nel cuore ogni volta che si guarda il mare.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Middle England, middle class, middle age.
Non c’è dubbio: Jonathan Coe è uno scrittore geniale, di sicuro uno dei migliori scrittori inglesi, che unisce al dono della narrativa una verve satirica e un’acuta capacità di analisi degli eventi sociali e politici del suo tempo.
Con il suo ultimo romanzo “Middle England” egli ci ripropone i personaggi de “La banda dei brocchi” e di “Circolo chiuso”, seguendoli nel corso degli ultimi otto anni del nuovo millennio. Siamo dunque di fronte a un Benjamin, un Doug e una Lois ormai giunti alla maturità, con tanti dubbi e tante ansie nient’affatto risolti. A Sophie, figlia di Lois, l’eredità complessa e confusa di un mondo caotico con poche certezze e tanti limiti.
Ciò che più sta a cuore a Coe è descrivere la situazione politica e sociale in cui si è trovata la Gran Bretagna dal 2010 ad oggi. A Doug il compito di denunciare la crisi e il declino del partito laburista, responsabile di aver causato l’impoverimento della media e piccola borghesia, lasciando immutati i privilegi di pochi. È Doug che riconosce, in un incontro con Ben, che la gente è stanca, rabbiosa e disgustata. Né le cose sembrano migliorare con l’avvento dei Tories di Cameron, sicuro di sé al punto da indire un referendum sulla Brexit, con l’impegno di restare a risolvere i problemi del paese nel caso d’un voto favorevole all’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, promessa che non avrebbe mantenuto, lasciando a Theresa May il compito di rispettare la volontà popolare. Ed è attraverso i personaggi di Ben, Lois e Doug che possiamo constatare con quale drammatica consapevolezza si sia vissuta e si viva tuttora una decisione destinata ad avere un’influenza determinante sulla vita di ciascun individuo. La nazione sembra letteralmente divisa in due: da una parte c’è chi, come il padre di Lois e Ben, legato ancora ai ricordi del passato, vorrebbe che al suo paese fosse restituita quella sovranità che gli è stata tolta con la sua adesione all’Europa, dall’altra chi ritiene che far parte dell’Europa sia un’opportunità da non perdere. Ciò di cui tutti si rendono perfettamente conto è che la politica di austerità che l’Europa ha imposto ai suoi membri ha impoverito il paese, trasformando persino il territorio, in seguito alla chiusura di fabbriche e industrie per far posto a attività commerciali. “Un edificio non è solo un posto, non ti pare?” – dice Colin a suo figlio Ben – “E’ anche la gente. La gente che ci sta dentro […..] Se non produciamo niente, non abbiamo niente da vendere, perciò come faremo a sopravvivere?”
Ben, Doug e Lois vedono accentuarsi intorno a loro uno strisciante sentimento xenofobo e sovranista, aumentare l’intolleranza per l’avversario politico, atteggiamento che raggiunge il momento culminante con l’assassinio della deputata Jo Cox.
Pur mantenendo una posizione equilibrata ed equidistante verso la problematica della Brexit, sembra tuttavia che Coe lasci trasparire il suo rammarico di vedere il suo paese chiudersi nuovamente in un isolazionismo che ha comunque sempre caratterizzato la sua politica, pur riconoscendo che un’Europa così fondata su rigide regole economiche e nessuna politica comunitaria non può che vedere rinascere i nazionalismi e avviarsi ad una chiusura sempre più drastica delle frontiere. Cosa che non può che palesare il fallimento degli ideali sui quali l’Europa avrebbe dovuto fondarsi.
L’originalità di questo romanzo consiste proprio nell’aver messo l’accento su come la politica influisca in maniera determinante sulla vita dei singoli individui, con i suoi personaggi borghesi di mezz’età nell’ Inghiterra delle Midlands.
Middle England, Middle class, Middle age.
Indicazioni utili
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Beviamoci sopra (un caffè)
Il nuovo libro di Eggers è chiaro e ben scritto ma di tipo documentaristico. Il protagonista, Mokhtar, un nome una garanzia,è uno yemenita trapiantato in America, che aspira a mettere su un’impresa commerciale del caffè tra MoKha (Yemen) e il mercato USA. Lo Yemen, MoKha in particolare, è la terra natale del caffè come viene fin troppo dettagliatamente ricordato.
Nel testo sono descritte tutte le tappe della realizzazione del sogno dall'ideazione alla attuazione attraversando difficoltà di ogni tipo. Ci sono anche ricadute positive per il paese in guerra dove il lavoro scarseggia e è mal pagato. Il nostro eroe dovrà diventare prima un Q grader, cioè un esperto sommelier della variante arabica del caffè (la variante robusta richiede un esperto con una diversa specializzazione); poi apprendere alcune nozioni sulla coltivazione e lavorazione della materia prima, trovare i finanziatori, non farsi ammazzare dalla concorrenza a volte sleale, e infine riuscire a esportare il caffè dal paese in guerra. La storia è vera. Il protagonista, Mokhtar, ha doti affabulatorie non di poco conto. E’ un Perlasca yemenita, che anziché salvare esseri umani grazie alle sue doti di improvvisazione riesce a realizzare un’impresa non certo meno difficoltosa, anche se per il lettore meno coinvolgente.
Il libro è ben scritto e ben documentato. La narrazione resta però asettica, asciutta, senza gli slanci inventivi o umanitari di Eggers, quelli per cui uno corre a comprare i suoi libri. Anche la parte avventurosa dell’attraversamento del paese in guerra a me è sembrata poco coinvolgente. Per esempio Ologramma per il re a me è piaciuto molto di più dal punto di vista narrativo, anche se l’argomento potrebbe essere simile. Forse è la storia in sé che non merita un intero libro.
Gli aspetti più interessanti sono quelli marginali: il quartiere povero in cui Mokhtar vive con la famiglia in America, la storia del nonno yemenita che ha perso la sua parte di eredità per la gelosia dei fratelli quando lui solo è chiamato al capezzale dal padre morente. Il ragazzo chiede una capra e rinuncia al resto dell’eredità ma gli viene rifiutata pure quella (la capra vale più di te) per cui parte senza la capra. Ma poi ha successo e manda soldi a casa alla madre (da quello che vale meno di una capra). Sembra una storia biblica, bellissima. Quella storia avrei voluto leggere!
Alcuni aspetti della vita nello Yemen sono interessanti. Mentre la tensione al successo e all'integrazione del protagonista, non so, mi sembrano una perdita. Certe dinamiche politiche e culturali o sociali che pure avrei approfondito volentieri non sono state esplorate dato che superflue per il racconto. Il libro non è narrativa, ma un resoconto giornalistico (ben fatto) della rocambolesca realizzazione del sogno americano di uno yemenita ben integrato. La storia a me non è sembrata molto interessante né per l’argomento né per il taglio che le è stato dato. Magari può essere un esempio di come si mette su una attività commerciale equa e solidale unendo utili e giustizia sociale (seppur relativa).
Potrebbe essere interessante da proporre ai ragazzi delle scuole di ragioneria o agli studenti di economia. C’è anche una descrizione dettagliata della pianta del caffè e della sua coltivazione nonché malattie e metodi di scelta dei chicchi (rossi e non verdi) e via discorrendo. Per cui forse andrebbe bene anche per gli studenti degli istituti agrari.
Indicazioni utili
- sì
- no
La baita maledetta
Il protagonista di questo romanzo decide di omettere il suo nome, per quanto riguarda il resto invece, è molto quello che racconta di se, forse anche troppo.
Maledetto è il giorno in cui decide di ristrutturare la vecchia baita che si trova spersa nel bosco, ad attenderlo, nascoste nel muro, ci sono tre mummie, sicuramente di donne, con strani segni addosso scritti in una lingua incomprensibile. Quelle mummie diventeranno la sua ragione di vita e la sua ossessione, saranno le “sue donne”.
Nato in una famiglia maledetta, per tutta la vita il suo pallino fisso sarà l’odio nei confronti delle donne. Un odio che nasce e cresce fin da piccolo, circondato anche da familiari e amici misogini. Per il genere femminile non ci sono mai belle parole, solo pensieri orribili e atteggiamenti non proprio delicati, ma dove lui non riuscirà ad arrivare, ci penseranno gli altri a completare l’opera.
L’incontro con le tre mummie diventa un lungo viaggio, ricco di digressioni in cui il protagonista spesso perde il filo del discorso per immergersi in altri pensieri e altri dettagli che spesso stancano il lettore o che nel mio caso non reputo così fondamentali. Spesso diventa ripetitivo, in alcuni casi monotono con ripetizioni su ripetizioni, che in un romanzo di 280 pagine, tolgono molto alla trama. Una trama che mi chiedo ancora perché scriverla.
In quella natura incontaminata sono molte le cose che accadono, alcune non sappiamo se “fantasiose” oppure “influenzate” dall’uso continuo da parte del protagonista di alcol e belladonna.
Nella prefazione si parlava di un libro commovente, appassionante e intenso. Personalmente ho trovato questo libro pieno di odio nei confronti delle donne e del genere femminile in generale. Un libro che mi ha lasciato molto disgusto e un’immagine delle persone non buono. Tutto il bello che riguarda la natura, nel mio caso è passato in secondo piano anche perché leggere cose così orribili, fatte alle donne, mi ha tolto tutta la fantasia per il resto.
Buona lettura.
Tre donne, tre vendette.
Il suo nome è Ingrid Steen, è la moglie di Tommy Steen uno dei più rinomati giornalisti del momento in Svezia nonché direttore dell’Aftonpressen, ed è la madre di Lovisa, figlia nata dall’unione e di cui si occupa a tempo pieno essendo stata costretta a lasciare il lavoro, a sua volta di report, per sopperire alle volontà del marito che la voleva a casa ad occuparsi della prole. Ha di recente scoperto, oltretutto, che quest’ultimo ha ricominciato a tradirla.
Il suo nome è Victoria Brunberg, ha venticinque anni, è di origine russa e dopo aver perso in una uccisione il compagno Jurij, è stata comprata come “moglie per corrispondenza” da Malte, svedese, violento, ubriacone, in sovrappeso e con scarsa cura della propria igiene personale. La tiene segregata in casa in una piccola proprietà sperduta nei boschi oltre Stoccolma perché lei è una sua proprietà e deve fare quello che vuole, come e quando lo vuole.
Il suo nome è Birgitta Nilsson, è una maestra delle scuole elementari, è la maestra di Lovisa. Apparentemente la sua vita è calma, ha un marito e due figli gemelli di venti anni, la sua indole è pacata e il suo carattere mite. In realtà ha un atteggiamento verso il mondo di auto-colpevolezza, perché la sua quotidianità è fatta di violenza e di errori che le vengono sempre e immancabilmente imputati da parte del marito che nei momenti in cui è certo di non essere visto e nei punti in cui sa perfettamente non esistere visibilità, non manca di sferrarle colpi brutali che le lasciano ecchimosi nel corpo e nella mente.
Tre donne, le protagoniste di quest’ultimo romanzo in anteprima mondiale di Camilla Lackberg, le cui strade si incontrano grazie a FamiljeLiv.se per non separarsi mai più. Perché è ora di dire basta, di vendicarsi dei soprusi subiti, di liberarsi di questi sposi che le tradiscono, maltrattano, picchiano. E quale miglior piano se non unire le forze in quello che è un omicidio camuffato da tragico incidente?
Con una penna rapida che tocca le corde più intime del lettore soprattutto per quanto riguarda le angherie che è costretta a subire Victoria, l’autrice svedese costruisce un romanzo dal buon intreccio narrativo e da una trama che funziona. Peccato però che talvolta si contraddica (ed es. la stessa Victoria prima non sa guidare la macchina e quindi non può prendere il furgoncino di Malte per scappare e poi invece addirittura vi si mette al volante perché Jurij le aveva insegnato a guidare una Mercedes), che tenda a cadere nel prevedibile e che vuoi per il tema attualmente in voga, vuoi perché di recente è uscito in Italia un romanzo dalla stessa impostazione e con problematica annessa e più precisamente “Sbirre” di Carlotto, De Giovanni e De Cataldo, il testo tende ad avere quel tratto comune del deja-vu. Non stupisce dunque che si concluda in pochissime ore e che lasci una sensazione piacevolezza ma non indimenticabilità. Una buona prova ma certamente non la migliore della Lackberg.
Indicazioni utili
- sì
- no
Risvegli quotidiani
"Souvenirs dormants", il titolo in lingua originale non viene tradito ma solo tradotto e permette proprio una lettura di questo breve, emblematico, potente lavoro del Nobel francese tutto giocato su due dimensioni vitali per l’essere umano: il ricordo e il sogno. Spesso, capita a tutti noi, soprattutto quando i giorni accumulatisi in anni si sono adagiati in un’identità che faticosamente abbiamo costruito e della quale mancano i particolari, perché offuscati da un ricordo non nitido, non oggettivo, non reale ma trasfigurato da pericolose sovrastrutture che ci hanno complicati, le due dimensioni si mescolano, si confondono e determinano nuove verità. Il tutto in fondo rimane misterioso, come la nostra esistenza, fatta di relazioni importanti ma costellata di comparse. Persone che abbiamo appena incrociato, in periodi brevi della nostra vita, incontri fugaci, apparentemente insignificanti che prepotentemente tornano in altre stagioni della vita, nel sogno, nel ricordo, nella rimembranza non casuale ma cercata o più semplicemente attraverso un ennesimo, fortuito incontro. E così, possiamo ripercorrerla la nostra esistenza incastonandola anche in una perfetta geografia: luoghi e ambienti che con la loro fisicità, con la loro presenza, richiamano il ricordo senza però mantenerlo, conservarlo o sigillarlo, poveri custodi di un effimero transitorio che è libero, passeggero, difficilmente intrappolabile. La geografia del ricordo in questo scritto è quella degli spazi esterni di Parigi, quei luoghi che già Modiano ha riesumato in altri suoi romanzi imprimendogli una forte potenza evocatrice, l’universo delle comparse è invece tutto al femminile in un andamento a ritroso che copre la vita di un uomo a partire dal suo debutto da giovincello nei misteri di Parigi. E ora, da vecchio, Parigi è popolata di fantasmi e il narratore si confonde con l’autore e la consapevolezza dell’errore insito nel proprio vissuto amareggia per la sua fuggevolezza:”se potessimo rivivere alle stesse , negli stessi luoghi e nelle stesse circostanze ciò che abbiamo già vissuto, ma viverlo molto meglio della prima volta…”.
Splendida lettura, ve la consegno con grande convinzione.
Indicazioni utili
UNA STORIA CHE POTEVA DARE DI PIU'
Un’estate, un ragazzo, la maturità ma anche un’occasione per crescere per diventare grandi, per affacciarsi al mondo del lavoro.
Un’estate che segna il cambiamento, forse un passo per andare verso l’età adulta.
Un’estate di bilanci e di nuovi inizi dove tutto viene messo in discussione anche se stessi. E’ giusto bruciare le tappe e non viversi l’ètà in cui viviamo? E’ però anche giusto non cogliere l’attimo e l’opportunità che ci si presenta davanti?
A volte correre troppo è sbagliato e alcune volte no.
Max questo lo sa, sa che nella sua estate della maturità tutto può accadere, come dover scegliere cosa fare del suo futuro, ma questa volta la decisione la può prendere solo lui.
La storia di questo ragazzo rappresenta in maniera molto veritiera quello che succede oggi ai giovani, che vogliono tutto e subito e non conoscono la gavetta o il sacrificio per arrivare. Questo lo vediamo tutti i giorni grazie a internet, ai social dove si creano fenomeni solo grazie ai follower e a niente altro. Solo chi ha talento resiste, va avanti e non sarà solo un fuoco di paglia.
Max ha una dote incredibile, ci sa fare con il computer ma come accade oggi per caso il suo talento viene riconosciuto e gli darà la possibilità di trasferirsi a Roma e iniziare a lavorare per una start up. Una notizia che gli sconvolgerà la vita.
Le cose cambiano, il mondo del lavoro trasforma le persone e ti fa maturare, non sei più “protetto” dalla scuola ma te la devi cavare da solo e anche riconoscere le tante insidie che si creano all’interno di un ufficio, come in un negozio, in un bar ecc. In qualsiasi ambiente tu sia, ora te la devi cavare da solo.
La generazione Z, di cui Max fa parte, chiamata anche Millennial, si distinguono per la loro velocità mentale, per la voglia di cambiamento in una continua corsa verso il nuovo e sempre alla ricerca di conquistare qualcosa di più. Sono cresciuti fin da piccoli con internet, sono intelligenti, perspicaci ma anche più presuntuosi e alcune volte indisponenti.
In queste pagine ho visto quanto rispetto alla mia generazione questa fosse diversa, molto lontana, questi ragazzi nascono già pronti, pieni di sogni, aspirazioni e lottano per riuscire ad arrivare, per loro non c’è tempo da perdere. Per loro non esiste la parola non riuscire, o almeno ci provano in tutti i modi.
Per quanto possa apprezzare che un ragazzo giovane e anche della provincia di Padova, come lo sono io, arrivi a pubblicare con una casa editrice importante come la Einaudi, non capisco come si possibile leggere una storia così semplice. Tutto è lineare, lo stile pulito, semplice, diretto, con alcune parolacce, ma manca sempre qualcosa, forse l’emozione. Un appunto però lo farei, meglio scrivere gay che non dei termini dispregiativi soprattutto del nostro dialetto, che risultano offensivi in un mondo dove le differenze sono sicuramente un valore aggiunto e non un motivo di regressione. Strano che nell’editing questo termine sia passato inosservato.
Certo è un romanzo attuale, che descrive sicuramente i giovani d’oggi, ma è solamente una storia che possono leggere i ragazzi o è anche per gli adulti? Io non sono riuscita ad entrare nel mondo di Max, a capire le sue problematiche, i suoi dubbi, i suoi dilemmi, forse abbiamo età troppo diverse, che poi una decina d’anni cosa sono? Eppure mi sono resa conto di come la mia maturità e tutto il resto sia stata molto diversa da quella che ha vissuto il protagonista o da quella che vivono i giovani d’oggi.
Quello che manca secondo me è qualcosa che spinga il lettore a emozionarsi, mi sembrava di avere tra le mani qualcosa di già sentito, già visto e forse questo è il limite di questo romanzo.
L’idea sicuramente è buona ma qui siamo di fronte ad una domanda, perché casa editrice come Einaudi pubblicano questi libri? Me lo sono chiesta prima di iniziarlo e dopo averlo finito non mi sono data una risposta. Nulla di nuovo, eppure secondo me questo ragazzo può fare di più, anzi sicuramente farà di più.
Un’altra cosa che vorrei far notare è la discrepanza tra il titolo “Gli squali” con il disegno della copertina, sono chiaramente dei capodogli, questa differenza è dovuta a qualcosa?
Forse non sapremo mai la risposta ma mi sembra molto strana una cosa del genere.
Auguro all’autore di continuare a scrivere e la prossima volta di regalarci una storia diversa e più vera.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 09 Novembre, 2018
Opinione inserita da ornella donna 09 Novembre, 2018
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
L'uomo Leonardo Da Vinci
L’uomo di cui si parla nell’ultimo libro di Marco Malvaldi, dal titolo La misura dell’uomo, è sicuramente eccezionale, e ha lasciato una profonda orma nella cultura. Stiamo, infatti, parlando nientedimeno che di Leonardo da Vinci. Un protagonista eccellente intorno al quale l’abile penna di Marco Malvaldi costruisce un giallo storico impeccabile e di grande pregnanza letteraria. A cinquecento anni dalla morte di Lenardo Da Vinci, l’autore racconta una storia che non può non affascinare. Siamo molto lontani dalle atmosfere del Bar Lume a cui Malvaldi ci aveva abituato; ma in comune con i predetti c’è sicuramente un tratto che caratterizza queste narrazioni, ed è la forte ironia che le pervade. Un’ironia qui soffusa ma precisa e puntuale, che colpisce indistintamente, sia di Ludovico il Moro e la sua corte, sia di Beatrice d’Este che dello stesso Leonardo.
Gli ingredienti fondamentali di questo testo sono:
“Un taccuino segreto. Una morte inspiegabile. Un genio che a distanza di cinque secoli gioca con la nostra intelligenza e ci colma di stupore.”.
Siamo nell’ottobre 1493 e Ludovico il Moro ha commissionato a Leonardo la costruzione di un enorme statua equestre. La sua fama va di giorno in giorno aumentando, e lui è un uomo che vive con la madre Caterina, e uno strano quanto dispettoso ragazzetto , Salai, che lo aiuta nei lavori di bottega. Ha idee straordinarie, che precludono i tempi, ed è solito aggirarsi per il Castello Sforzesco indossando una veste di panno rosa, sotto la quale nasconde un taccuino su cui appunta continuamente idee e teorie. Inoltre è vegetariano e si dice omosessuale:
“Avete ragione madre. Io faccio cose contro natura. Anzi, a essere preciso, faccio una e una sola cosa contro natura. E sapete qual è? (…) Non mangio carne. Non mi nutro dei resti di altri animali a me inferiori, uccisi da me o da altri non importa, come fa la gran maggioranza delle bestie in natura. Ingozzarsi di carne di animali più deboli è cosa secondo natura, e io non solo non lo faccio, ma la aborro.”.
In un contesto simile un uomo viene trovato morto all’interno della Corte stessa; non si capisce di che cosa sia deceduto, visto che non ha segni di violenza, eppure… I malevoli si scatenano, e la superstizione è in agguato. A Leonardo su richiesta dello stesso Ludovico non rimane che tramutarsi in detective per aiutare il suo Signore. Dunque un Leonardo insolito, ma non meno intelligente, affascinante, abile artista e precursore delle scienze. Bellissime e precise le descrizioni che riguardano l’organizzazione e la vita delle botteghe d’artista del periodo, per cui:
“Ogni artista, a quei tempi, aveva in casa un pollaio, e non per motivi alimentari. All’epoca di Leonardo, la tecnica per dipingere ad olio non era ancora padroneggiata appieno: nella Firenze del Quattrocento si dipingeva spesso a tempera, cioè mescolando – temperando, dal latino, anche se Leonardo il latino non lo sapeva, ma la procedura funzionava lo stesso- i pigmenti con una parte legante, come il rosso d’uovo, il quale seccando avrebbe formato un reticolo proteico in grado di attaccarsi alla superficie e di ingabbiare i colori in Aeternum. (…) ogni artista per avere a disposizione uova fresche faceva la cosa più ovvia, cioè teneva un pollaio in casa. Proprio da lì incominciava.(…) Prima di appoggiare un pennello sulla tavola, passava del tempo.”.
Abile e precisa è anche l’elaborazione del sistema bancario dei tempi, che nel testo ha un ruolo determinante:
“La banca è come un giocoliere. Tiene in equilibrio i denari degli altri, e ogni qual volta che tocco la moneta altrui, a me rimane ben poco in mano. Ma anche se tengo in aria dieci piatti, in mano me ne rimane sempre uno solo, e nemmeno quello è mio.”
Una lettura che mi ha fatto tornare indietro nel tempo, mi ha fatto apprezzare gli studi e la cultura dell’epoca, la lingua, la scienza. Perché certamente Leonardo è stato un genio assoluto, che possedeva infinite capacità, tra cui:
“Questa capacità rende l’uomo simile a Dio: quella di inventare cose che non esistevano prima, e dare loro significato. Ogni uomo può dar forma, nella sua testa, a oggetti che non esistono, e convincere gli altri che tali oggetti esistono, o esisteranno.”.
Un romanzo giallo storico multiforme, dalle mille facce e dai variegati e disparati argomenti. Una trama geniale, personaggi perfettamente descritti e delineati, una prosa accattivante ed affascinante. Una eccezionale lettura “d’artista”!
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Lo “spleen” in salsa yiddish
Shraga Unger è un vecchio conferenziere, anzi, come lui stesso tiene a precisare, è un vecchio conferenziere malato, ridicolo nonché del tutto superfluo e fastidioso. Si guadagna da vivere tenendo pubblici discorsi nei kibbutz sparsi sul territorio di Israele durante gli ultimi anni ’60. Si è fossilizzato su un unico argomento: l’ebraismo nell'URSS e, dopo aver sperimentato sulla sua pelle la durezza dell’antisemitismo sovietico, è giunto a tal punto di paranoia da incentrare i suoi monologhi solo sulla minaccia bolscevica che lui afferma essere perennemente incombente. Egli stesso teme che proditori attacchi ad Israele da parte dell’orso russo possano venir mossi nell'immediato futuro, come primo passo verso la conquista del Mondo. Si documenta, legge compulsivamente ogni notizia disponibile, accumula giornali e lettere da oltre cortina per comprovare i suoi timori. Per il resto, trascina la sua vita in un grigiore infinito, ripetendo ogni giorno, meccanicamente, gli stessi gesti, gli stessi rituali, senza alcun entusiasmo. L’unico barlume di affetto, per la cantante Ljuba che negli anni pregressi lo aveva accompagnato nei suoi giri di propaganda, è anch'esso ammuffito con lui. Alla fine pure l’ardore antibolscevico si affievolirà, travolto dalla marea montante della sua amarezza cosmica. Shraga, mestamente, accetterà il suo inevitabile accantonamento ai margini di una società che ormai non comprende più.
Anche il Conte Guillaume di Touron, signore di un piccolo feudo nei pressi di Avignone, è afflitto dal male dell’esistenza. Inoltre, giacché egli ha dilapidato tutte le sostanze di famiglia, è carico di debiti. I suoi vigneti sono afflitti da una malattia misteriosa, le bestie si ammalano e i contadini sono inquieti e ribelli. Vivendo a metà dell’undicesimo secolo l’unica soluzione che individua per tentare di risolvere le sue inquietudini interne ed esteriori è partire con tutto il suo seguito per unirsi alla Crociata cristiana in Terra Santa. Ma il viaggio, lungo e difficoltoso, non fa che acuire le sue ansie ed i suoi intimi turbamenti. Nonostante gli incoraggiamenti ed i “saggi” consigli del parente Claude “Spallastorta” (cronachista della vicenda), la depressione che lo affligge non fa che accrescersi. Addirittura pare estendere i suoi nefasti effetti a tutta la missione. Evidentemente un ebreo si è infiltrato nella corte e sta ammalorando i migliori intenti di buon cristiano del Conte. Ma, ahimè, non si riesce ad individuare il maligno infiltrato. Così, anche quando il gruppo di ardimentosi crociati entrerà nei territori in cui allignano fiorenti comunità ebraiche, la gioia di poter glorificare il Signore torturando e mettendo a morte gli assassini di Cristo, incendiandone le proprietà e confiscandone i beni, non recherà alcun giovamento all'impresa o al morale complessivo. Quando l’inverno comincerà ad imperversare sulla carovana ogni speranza di vedere l’agognata Gerusalemme svanirà nel dolore e nell'afflizione.
I due racconti di cui è composto il volumetto di Amos Oz sono assai distanti per contenuti, epoca di ambientazione e stile narrativo, ma sono improntati dal medesimo pessimismo cosmico e dagli stessi malesseri esistenziali; dalla stessa noia ed accidia. Li accomuna identico disagio, medesimo “spleen”. Per altro il concetto di spleen trova le sue radici proprio nella cultura ebraica e queste due storie lo sostanziano perfettamente.
L’immanente pessimismo di Shraga, che è costantemente costernato dalla minaccia bolscevica, non è per nulla dissimile dalla cupezza che ammanta il gruppo di improbabili crociati di Guillaume. Il primo scarica i suoi umori malsani nelle inutili (ed inascoltate) filippiche in sperduti kibbutz, i secondi, non riuscendo, per loro intrinseca inettitudine, a raggiungere la Terra Promessa di Gerusalemme si accaniscono sui poveri malcapitati che si trovano ad incrociare, non rendendosi conto che il vero nemico è nei loro cuori, nel loro animo preda di una depressione cupa, angosciosa, dalla quale non riusciranno a fuggire.
Alla fine della lettura ci resta addosso una sensazione malsana, un senso di depressione generalizzato, di insofferenza e repulsione anche nei confronti dei protagonisti e delle loro storie.
Prima di affrontare questi due racconti non conoscevo la prosa di Amos Oz e da essa sono restato per un verso sorpreso e, per l’altro, profondamente incupito, come se la depressione dei protagonisti fosse infettiva.
Lo stile letterario è ricercato e profondo e di questo si deve rendere merito anche all'ottima traduzione in italiano. Tuttavia il soliloquio del primo racconto alla fine risulta un poco pesante da seguire: instilla quello stesso fastidio che Shraga stesso ammette di ingenerare nel prossimo (e forse questo è un ulteriore punto a favore dell’A.).
Le considerazioni in esso svolte oggi ci appaiono datate. Il racconto, all'atto della stesura, aveva una ambientazione contemporanea, infatti “Amore tardivo” è del 1970, cioè della medesima epoca nella quale l’io narrante, Shraga, ci parla. Tuttavia i cambiamenti epocali che il Mondo nel frattempo ha subito ci fanno apparire i cupi rimescolii mentali del conferenziere ancora più muffiti ed incoerenti. Al contrario appare ancora più evidente il patologico scoramento nella personalità del protagonista.
Il secondo racconto, eponimo della raccolta, risulta più leggibile, forse anche grazie al crudele sarcasmo con cui ci viene mostrato il Medioevo cristiano, cinicamente descritto col freddo distacco di chi, pur discendendo dalla genealogia di vittime di quelle “Sante guerre”, lo esamina come un analista di laboratorio.
In complesso la breve antologia, pur non risultando affatto piacevole (ma non penso neppure che questo fosse l’obiettivo dell’A.) è, comunque, un’ottima lettura scritta in modo raffinato e interessante.
Indicazioni utili
La strana serenata
Arriva in libreria la nuova edizione di un racconto di Kazuo Ishiguro, “Crooner”, che era già stato pubblicato da Einaudi nel 2009 e faceva parte della raccolta “Notturni. Cinque storie di musica e crepuscolo.”
Si tratta di un oggetto degno di nota, una bella edizione dei Supercoralli impreziosita dalle originali illustrazioni della bravissima fumettista Bianca Bagnarelli: un libricino che sarà sicuramente un piacere avere nella propria libreria o regalare a chi lo saprà apprezzare.
Tornando al testo però, devo ammettere che avrei preferito poter leggere tutti i racconti della raccolta, che comunque sono legati dallo stesso tema e che, immagino, avranno un denominatore comune che non può essere compreso appieno dalla lettura di un solo racconto.
Detto questo, arriviamo a “Crooner”.
La voce narrante, Jan, un chitarrista originario di un Paese ex-comunista che lavora a Venezia, suonando nelle orchestre dei locali del centro, ricorda uno strano episodio che gli capitò di vivere all'inizio di una primavera come tante. Mentre suonava in piazza san Marco, al caffè Lavena, in una ventosa mattina di marzo, vide e riconobbe fra i turisti Tony Gardner, un cantante americano ormai di mezza età, di cui era un'accanita fan sua madre. Il personaggio famoso infatti era stato importante per la mamma di Jan, che ascoltando le sue canzoni aveva potuto continuare a sognare. E' per questo che il nostro chitarrista tiene tanto ad andare a conoscere personalmente Mr Gardner. Il vecchio cantante, il crooner, si mostra subito aperto e disponibile nei confronti del giovane, soprattutto quando comprende che è un musicista e gli fa una richiesta particolare: aiutarlo a fare una serenata a sua moglie Lindy, con la quale è sposato da ventisette anni.
“-Continuo a non capire, Mr Gardner. Il mondo suo e di Mrs Gardner non può essere tanto diverso da quello di tutti gli altri. È per questo, Mr Gardner, precisamente per questo motivo che le sue canzoni da anni e anni significano tanto per gente che vive ovunque. Perfino dove stavo io. E che cosa dicono quelle canzoni? Che se due smettono di amarsi e devono separarsi, è un peccato. Ma se si amano ancora, hanno il dovere di restare insieme per sempre. È questo che dicono quelle canzoni.”
L'ingenuo Jan rimarrà molto sorpreso dopo aver suonato con Tony Gardner quella sera, su una gondola, a Venezia: ci sono mille diverse motivazioni che inducono una coppia a rimanere insieme, ed altrettante che la inducono a separarsi.
Una strana malinconia attraversa questo racconto, sicuramente accompagnata da una sottile ironia che prende in giro l'improbabile rilancio di chi in passato aveva incarnato, con le sue canzoni, la speranza e il sogno di libertà, ed ora invece si mostra nel suo ridicolo egocentrismo e nella sua esasperata superficialità.
In conclusione, una buona lettura che ci parla di “musica e crepuscolo”.
Indicazioni utili
Vincoli. Vincoli
«Edith Goodnough meritava di essere vista in quella pallida luce azzurra, e comunque so che le stelle brillavano per loro nel cielo terso e c’era un grande silenzio.»
È la primavera del 1977 a Holt, Colorado. Edith Goodnough sta per compiere ottant’anni, è una vecchia signora con i capelli bianchi eppure è ancora elegante e bella come doveva esserlo nel 1922 quando di anni ne aveva soltanto venticinque e quando nei suoi occhi brillava la luce per quei brevi attimi vissuti, con quei finestrini di una vecchia Ford T abbassati, con la notte che scorreva tra la quotidianità di una vita che mai le era ed è appartenuta. Nell’oggi giace in un letto bianco dell’ospedale della città, non vive più in campagna, pesa ancora meno dei cinquanta chili che non ha mai pesato, del suo passato non resta altro che il rudere di una casa e un cane che uggiola legato in attesa di due coccole e di un pasto e nel suo presente e futuro pende una grave accusa. Perché lo sceriffo e gli avvocati attendono che le sue condizioni di salute migliorino esclusivamente per metterla su una sedia a rotelle e condurla in tribunale, dall’altra parte della cittadina, luogo dove verrà sottoposta a processo e giudicata per un crimine che riguarda suo fratello Lyman e di cui lei pare essere l’artefice. Un cronista di Denver, un articolo che in parte è vero ma che in realtà non è altro che parte di una parte della storia, uno sceriffo che non è altro che un figlio di buona donna, un vicino di casa di nome Sanders Roscoe, un uomo sulla cinquantina, tarchiato, testardo e da sempre legato ai due fratelli Goodnough. È lui che si scaccia quel reporter, è lui che si rifiuta di parlare con il giornalista di fatti di cui non dovrebbe conoscere nemmeno l’esistenza, è lui che si fa voce narrante di questa piccola perla a firma Kent Haruf.
E così torniamo nel passato. È la tarda primavera del 1896 quando Roy Goodnough e sua moglie Ada Twamley giungono dall’Iowa a quella che poi sarebbe diventata la Holt, Colorado, che abbiamo conosciuto con la Trilogia della pianura. Quelle che si trovarono di fronte allo sganciare del loro carro, non erano certo le terre floride e ricche che si sarebbero aspettati dopo un così lungo viaggio, ma Roy era testardo e determinato. Aveva fretta, voleva piantare i suoi semi, costruire la sua vita in quel luogo prima che la compagna potesse risvegliarsi dal sogno del matrimonio a malapena consumato. Dopo un periodo di sopravvivenza, la costruzione della loro casa, la faticosa nascita della figlia Edith Goodnough nel 1897, quella del fratello Lyman Goodnough nel 1899. La prematura scomparsa della madre, i due figli adolescenti rimasti soli con quell’uomo. Un padre che non è un padre ma un padrone, un individuo pieno di rabbia e rancore che li costringe a restare al suo fianco, che obbliga lei a prendere il posto della madre, e Lyman a rilegarsi al ruolo di contadino che ara i campi e alleva le bestie senza possibilità di mutare la propria condizione. John Roscoe, al tempo un bambino, poi un adolescente, ancora un uomo adulto che mai viene ben visto da Roy perché per mezzo di sangue indiano, perché innamorato di Edith, perché elemento di disturbo nel suo astuto piano; assiste, osserva, non resiste. Perché soltanto lui, padre-padrone, era legittimato a decidere per i figli, a decidere del loro futuro, del loro presente e del loro passato. Un passato, un presente, un futuro, fatto di lui. A qualunque costo, a qualunque prezzo. E come meglio riuscire in questo progetto demoniaco se non avendo la fortuna nella sfortuna di sfruttare un tragico incidente? Un tragico incidente a cui sarebbe sopravvissuto per la bellezza di altri 37 prima che la morte si decidesse a portarselo via. A discapito dei fratelli, a discapito di Edith e della sua vita. Una donna che ha vissuto una vita in casa, una vita fatta di servilismo, una vita alimentata con il ricordo di un amore che mai ha avuto modo di sbocciare, una vita fatta di solitudine che non migliora nemmeno nella sua parte finale, anzi, peggiora.
Questo e molto altro è “Vincoli. Alle origini di Holt”, classe 1984, di Kent Haruf. Un romanzo forte, dove la voce narrante è Sanders, ma dove ogni protagonista è percepito con tutta la sua personalità disarmante nella sua seppur costretta condizione vincolante, un romanzo dove non mancano le tematiche care all’autore, non manca l’amore perduto, non manca la famiglia, non manca la solidarietà tra fratelli, non manca la separazione, non manca il sacrificio, non manca la lontananza, non manca l’abbandono, non manca l’isolamento, non manca la violenza che riveste i panni di quella tipica che si consuma nei luoghi domestici, non manca il dolore per la perdita, non manca il dolore per quella vita sfumata, per quel tempo passato che mai tornerà. E non manca ancora quello stile inconfondibile, che è magia e che è lama. Che è mistero e poesia, che è durezza e ferita, che è crudeltà. Il risultato finale è quello di un elaborato di grande spessore, di empatia e immedesimazione ai massimi livelli. Un altro piccolo gioiello che ci riporta tra i luoghi di Holt e che arricchisce la composizione a firma Kent Haruf.
«Edith aveva pianto. Indossava un vestito nuovo e si era un po’ sistemata i capelli, ma per il viso non era riuscita a fare niente. Il suo viso era andato in frantumi. La cinsi con un braccio.» p. 142
«[…] Ecco, sono passati quasi cinquantacinque anni, una vita intera, e lei ancora non ha imparato a dire a se stessa qualcosa che assomigli a un infinito sì.» p. 255
Indicazioni utili
Non sono perfetta neppure io
Sara Rattaro con “Andiamo a vedere il giorno”, torna a parlare della famiglia del precedente libro “Non volare via” letto da me diversi anni fa.
I nostri protagonisti sono cresciuti non solo “fisicamente” e la famiglia dopo la burrasca del precedente libro e anni di quiete si ritrova ancora in piena tempesta.
Se nell’altro libro la voce narrante era dell’adultero padre Alberto, questa volta la protagonista è Alice, la figlia che nel precedente libro aveva proprio beccato il padre con l’amante. Alice è una giovane donna che pur studiando e ancora molto giovane, si è sposata con il suo amore di una vita, Andrea.
“Ero lì. Io, la figlia perfetta, la moglie migliore, la sorella più affidabile” eppure il libro inizia con Alice appena lasciata dal marito e come in passato anche in questo caso, l’unica soluzione che trova è quella di fuggire, ma questa volta, mamma Sandra non la farà partire da sola anche per rimediare a delle mancanze che sente “Dalla nascita di Matteo, le nostre vite sono state stravolte e mi capita di pensare che il tempo dedicato ad Alice sia sempre stato troppo poco. Non avevo trascorso molti momenti da sola con mia figlia”.
Questo viaggio le farà crescere, unire e soprattutto riflettere e scoprire che alla fine non sono poi così diverse.
Sara Rattaro porta in questo libro il vero ruolo della famiglia. Ho apprezzato il suo non essere scontata e di rendere la perfezione poi non così perfetta. Alice da giudice si trova sul banco degli indagati e l’unica che può salvarla e “assolverla” è solo lei stessa.
Tutto si ripete ma non secondo gli schemi. L’unico che rimane sempre una spanna sopra gli altri è Matteo, sordomuto dalla nascita, che della sua famiglia ha veramente capito tutto, ma non la giudica, anzi la comprende e la ama fino in fondo.
Lo stile dell’autrice è molto semplice e comprensibile, il libro è diviso in piccoli capitoli in cui i punti di vista sono quelli dei vari componenti, anche se Alice è l’anello di congiunzione. La storia è riflessiva, io mi sono rivista nella vecchia Alice, quella inflessibile e convinta che certe cose non possano capitare a te, ma il vederla così fragile e in balia di se stessa mi ha fatto riflettere.
Non ho apprezzato in alcuni casi la brevità dei capitoli e soprattutto la parte in corsivo messa qua e là, per me invece che un ulteriore punto di riflessione era uno stacco dalla narrazione. Il finale poi è stato troppo breve, chissà se l’autrice ritornerà a parlare di questa famiglia speciale, sicuramente la voglia di sapere altro è rimasta.
Il libro si legge “in un soffio”, lo consiglio, anche se lo vedo più vicino a un pubblico femminile che maschile.
Buona lettura.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 06 Novembre, 2018
Opinione inserita da ornella donna 06 Novembre, 2018
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Il fascino dell'Himalaya
Paolo Cognetti, dopo aver vinto il Premio Strega con Le otto montagne, torna in libreria per esprimerci, ancora una volta, la sua passione per la montagna in Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya. Il racconto breve , ma intenso e passionale, di un percorso di viaggio, filosofico e molto intimistico. Un taccuino di viaggio, corredato anche si disegni, che:
“Disegnare mappe piaceva anche a me. Avrei tenuto un taccuino come il suo, nei momenti di riposo, su un quaderno nero che mi ero portato, robusto ma abbastanza morbido da stare arrotolato in tasca.”.
Paolo Cognetti è alla soglia dei fatidici anni quaranta, e vuole:
“celebrare l’addio a quell’altro regno perduto che è la giovinezza.”,
decidendo così di partire per un luogo un po’ particolare:
“partii per la terra di Dolpo, un altipiano nel nord ovest del Nepal dove avremmo superato passi oltre i cinquemila metri, viaggiando a piedi per circa un mese lungo il confine tibetano. Il Tibet era una meta che non si poteva raggiungere. (….) Però esisteva, o così mi avevano raccontato, un piccolo Tibet in terra nepalese sopravvissuto per qualche dimenticanza della storia. (…) c’è una regione tutta sopra i quattromila metri, non raggiunta dai monsoni né dalle strade, la più arida e remota e la meno popolata del Paese. Forse lassù, mi dicevo, avrei potuto vedere il Tibet che non esiste più.”.
Più che un viaggi è un pellegrinare:
“Gnaskor, ovvero girovagare: così vengono definiti i pellegrinaggi in Tibet. Un pellegrinaggio è in ogni cultura un cammino di purificazione, però nel girovagare, nel camminare in tondo, non c’è alcun punto di arrivo, che invece è fondamentale nei pellegrinaggi che intendiamo noi. “
Con lui c’è: un libro, Il leopardo delle nevi, di Peter Matthiessen,
“uscito nel 1978 e tuttora sui banchi di ogni libreria di Katmandu, (…) Anche quel libro aveva a che fare col mio viaggio, anzi in parte l’aveva ispirato, perché avrei percorso un buon tratto del sentiero descritto lì dentro.”.
E due amici di sempre: Nicola e Remigio:
“Nicola a cui mi legava un’amicizia nascente. Ci eravamo incontrati da poco, sentivamo di assomigliarci, ed eravamo nella fase in cui si ha tutto da scoprire l’uno dell’altro. (…) Remigio, l’amico più caro e difficile che avessi a quel punto della mia vita. Nei dieci anni della nostra amicizia non ero mai riuscito a portarlo via dal paese di montagna dov’era nato e cresciuto.”.
L’Himalaya, la loro meta, non è un luogo qualsiasi. E’ necessario organizzare una vera e propria spedizione, con l’aiuto di guide esperte, di muli resistenti alla fatica, e saper costruire un campo alla sera, per poi disfarlo la mattina successiva. E saper, soprattutto, sopportare gli sforzi, le difficoltà, i problemi che inevitabilmente si incontrano. L’autore non scala la montagna, non raggiunge la vetta, si limita ad osservarla, a conoscerla, ad amarla, perché:
“Trovavo un legame tra questo bisogno di città sante alla fine del cammino e l’ossessione alpinistica per le vette delle montagne: sentivo usare la cima come metafora del paradiso, e la parola ascesa in senso spirituale.”
Quello compiuto dall’autore è una specie di osservazione diretta sul campo, un allontanamento forzoso dalla civiltà, in forza di un cammino per cui:
“camminare era la nostra missione quotidiana, la nostra misura del tempo e dello spazio.”
Una ricerca precisa di un mondo nuovo, spirituale e profondo, lontanissimo dalla quotidianità del mondo occidentale, fatta da tecnologia, da telefoni che suonano e molto altro ancora. Per giungere al termine ad una discesa dove:
“quello che esiste è visibile agli occhi, non tutto è comprensibile, non tutto lo puoi cogliere e portare con te.”
Un libro che comunica una passione forte, decisa, bellissima, che è quella per la montagna che conduce l’autore a studiarne anche i segni invisibili che la caratterizzano, come:
“la purezza a cui accediamo , o abbiamo l’illusione di accedere salendo alla quota degli elementi si inquina in fretta tornando tra gli uomini, e con lei si intorbidisce la chiarezza di pensiero.”.
Un testo illustrato, dettagliato, una ricerca all’anima della montagna, alla sua spiritualità, e alla sua intima essenza. Un bel libro che si divora in un attimo, una prosa semplice e frizzante, che si addentra con minuzia nei contenuti espressi. Un elaborato di grande fascino ed eleganza.
Indicazioni utili
Il Re è (quasi) tornato
Finalmente uno dei miei autori preferiti torna a scrivere qualcosa che non mi abbia fatto storcere il naso. Sì, perché ultimamente la qualità dei suoi lavori (almeno quelli che io mi sono trovato a leggere) aveva lasciato alquanto a desiderare. "Il bazar dei brutti sogni" si era rivelata una raccolta di racconti di media qualità, mentre "Mr. Mercedes" e il suo seguito "Chi perde paga" mi avevano talmente deluso dallo scoraggiarmi nella lettura dell'ultimo capitolo della trilogia che aveva come protagonista Bill Hodges.
"The Outsider", finalmente, rimette un po' in luce la grandezza di Stephen King, pur rimanendo lontano dagli splendori de "Il miglio verde" ma anche del più recente "22/11/'63". Questa storia si è rivelata piuttosto originale, nella prima metà un poliziesco-noir puro e semplice, per poi trasformarsi, nella seconda metà, in qualcosa di più simile al King che ci ha spaventati tutti. Stranamente, ho apprezzato di più la prima parte (che ha anche certi picchi di puro King); la seconda mi ha appassionato meno e l'ho trovata anche più lunga di quanto avrebbe potuto essere.
Nonostante questa storia presenti per la maggior parte personaggi completamente nuovi, ritrova un collegamento con la trilogia di Mr. Mercedes, in qualche tema e in uno dei suoi protagonisti, Holly Gibney. Chi ha apprezzato quelle storie potrà sicuramente esserne soddisfatto; personalmente ha inquinato un po' il mio giudizio in negativo, ma è una cosa che non saprei spiegarvi razionalmente e dunque strettamente personale.
"The Outsider", dunque, lascia intravedere una piccola ripresa nel nostro amato King, sperando che presto possa sfornarci un nuovo capolavoro che sia all'altezza dei vecchi lavori.
Abbiate fiducia, gente; io adesso ne ho.
"The Outsider" comincia col brutale omicidio di un bambino, Frank Peterson. Un caso semplice, all'apparenza, considerando che sulla scena del crimine vengono ritrovate più tracce (tra impronte e DNA) di quante ne siano realmente necessarie, oltre alla presenza di vari testimoni oculari. Tutte queste prove indicano come colpevole un solo uomo: Terry Maitland, allenatore di baseball delle squadre giovanili, che mai nessuno a Flint City si sarebbe mai sognato di sospettare. Se hai un figlio, "Coach T" deve averlo per forza allenato, ed è così anche per il figlio del detective Ralph Anderson. Reso sicuro dalla mole di prove a sua disposizione, il detective arresta Terry davanti a quasi duemila persone, durante un match di baseball.
Terry è stupefatto dalle accuse che gli vengono fatte, ma ogni criminale simulerebbe tale stupore; peccato che, molto presto, a sostegno dell'innocenza di Terry verranno fuori prove in quantità industriale, che superano in mole e qualità quelle sollevate dall'accusa.
Ma allora chi ha ucciso Frank Peterson?
Né i nostri protagonisti né il lettore potranno mai immaginarlo prima della fine.
"[...] riflettere sulla propria sanità mentale probabilmente non era un buon segnale. Era un po' come pensare al battito del proprio cuore: se ti trovi nelle condizioni di doverlo fare, quasi certamente sei già nei guai."
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Quando l’ideologia si scontra con la realtà
Con il titolo Proletkult è stata pubblicata l’ultima opera del collettivo di autori che si firmano con lo pseudonimo Wu Ming. E’ un romanzo originale, con qualche rallentamento nel ritmo della narrazione quando si sofferma su alcuni aspetti filosofici che sono stati alla base delle teorie marxiste e leniniste sulle quali si è fondata la nascita dell’Unione Sovietica.
Osserviamo innanzitutto la copertina del libro edito da Einaudi Stile Libero: l’illustrazione di Riccardo Falcinelli rappresenta una falce e martello costituita da un assemblaggio di astronavi, siluri, razzi proiettati verso galassie sconosciute o immaginarie. Ciò ci porta immediatamente a pensare che il romanzo voglia da una parte descrivere la realtà degli anni venti in quella che ormai non era più la Russia degli zar, e dall’altra parte rappresentare il sogno di un mondo ideale e perfetto che avrebbe ormai potuto realizzarsi solo in una sfera ultraterrestre.
Illusione e disillusione sono i sentimenti che hanno albergato a lungo nell’animo di Aleksandr Bogdanov, il vero protagonista del romanzo, filosofo e politico oltre che medico, il quale aveva enunciato la teoria della tectologia, scienza secondo la quale ogni istituzione, ogni forma della società moderna deve essere basata su una rigorosa organizzazione delle strutture. Su queste basi nacque il Proletkult, un organismo fondato nel 1917, per creare un’arte per i proletari, che si liberasse del fardello delle ideologie borghesi. -“L’arte non è una decorazione. Come la scienza, serve a organizzare le esperienze. Ma a differenza della scienza non usa concetti astratti. Usa immagini vive.”
“Proletkult era il divenire, era lo spostamento del punto di vista, il movimento che cambia il modo di organizzare l’esperienza del mondo. Cioè la realtà.”
“Ho sempre pensato che costruire una nuova cultura fosse il modo migliore di difendere la rivoluzione.” “Se gli operai conquistano le fabbriche, ma non hanno una nuova cultura per organizzarle, finiranno per dipendere dagli ingegneri e dai tecnici che già lavoravano per i vecchi proprietari, oppure ne imiteranno l’opera, con risultati peggiori, e così la pretesa rivoluzione non produrrà un reale cambiamento, se non in peggio.”- così dice Bogdanov con la sua genuina onestà intellettuale, la sua consapevolezza che il sogno comunista delle origini fosse ormai svanito. Da questa disillusione aveva visto la luce quel mondo immaginario, perfetto nella sua concezione, il mondo di Nacun, che viene descritto nel suo libro Stella Rossa. Nacun è una sorta di Città del sole, in cui regna la legge universale dell’organizzazione: sembra evidente anche l’influenza de La Repubblica di Platone.
Da questo mondo ideale immaginario crede di essere giunta Denni, sempre alla ricerca spasmodica di un rifugio, che le permetta di sfuggire alla solitudine e al deserto affettivo della sua adolescenza. Denni, personaggio che vive tra realtà e immaginazione, desidera solo tornare a Nacun.
Su questa contrapposizione realtà-sogno si muove tutto il romanzo, e sulla base di questa contrapposizione, chiudiamo il libro sull’ultima pagina per tornare a osservare la copertina, in una naturale e istintiva chiusura del cerchio.
Indicazioni utili
Top 100 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
L'amore malato
Camille Preaker è una giornalista del Chicago Daily Post. Giovane e bella, molto bella, fisico longilineo e viso dai lineamenti delicati, un fascino tuttavia che non diventa appariscenza anzi, tutt'altro, rimane occultato, coperto.
Vestiti lunghi sempre, per nascondere i segreti del suo corpo, riflessi incondizionati del suo tormento interiore. Vive a Chicago, in un piccolo monolocale, completamente sola, niente piante o animali di compagnia, presenza umana ridotta al minimo indispensabile da quando, otto anni prima, ha abbandonato Wind Gap, una cittadina dispersa nel Missouri dove è nata e vissuta sino all'età adolescenziale.
"Un agglomerato piccolo e soffocante in cui eri costretto ogni giorno ad imbatterti nelle persone che odiavi. Persone che sapevano tutto di te. Il tipo di posto che lascia il segno."
Lascia il segno. Dentro, e fuori. Sulla pelle.
Un posto asfissiante per Camille che non trova ossigeno nemmeno a casa propria, in famiglia: nata da genitori poco più che diciottenni, il padre, un ragazzo del Kentucky mai conosciuto, la madre Adora unica discendente della più ricca famiglia del luogo. Ed anche unica superstite, visto che dopo la scandalosa nascita di Camille i nonni materni muoiono per la vergogna ed Adora eredita casa e patrimonio oltre a conquistare l'affetto e l'ammirazione dei suoi concittadini per la determinazione e la premura con cui si occupa di Camille e della piccola Marian nata dal matrimonio riparatore di Adora con Alan, un uomo 'insipido, con la profondità di una lastra di vetro'.
Ma l'amore Di Adora verso Camille è malato, morboso, opprimente; ciò che agli occhi degli altri potrebbe sembrare frutto di un istinto materno protettivo e benevolo è in realtà la manifestazione di un egoistico desiderio di controllo totale sulla vita delle persone a lei più vicine.
Camille, però, avverte sin da ragazza qualcosa di strano nel comportamento della madre, una sensazione che non riesce a decifrare bene inizialmente perchè Adora rimane pur sempre sua madre e non è facile per Camille interpretare correttamente i suoi gesti, non è semplice percepire nelle sue carezze e nelle sue parole la differenza tra amore materno e amore verso se stessa.
E' stata la morte improvvisa della sorella Marian a soli 10 anni a spezzare definitivamente il già labile legame che ancora tratteneva Camille alla sua famiglia e a Wind Gap convincendola a trasferirsi il più lontano possibile, in città, a Chicago, iniziando così la sua carriera di giornalista.
Ma non è stata forse una saggia decisione quella di accettare l'incarico da parte del suo capo per una trasferta proprio a Wind Gap con l'obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili in merito alla crudele uccisione di una bambina del luogo a cui il killer ha strappato via tutti i denti per motivi ancora sconosciuti, un caso stranamente simile ad un altro assassinio altrettanto violento avvenuto qualche mese prima sempre a Wind Gap. Non è solo l'opportunità di scrivere un buon articolo che induce Camille ad accettare l'incarico; c'è anche un inspiegabile desiderio da parte sua di ritornare in quel luogo dopo così tanti anni per capire, per tentare di ricostruire alcuni eventi della sua adolescenza che sono come offuscati nella sua memoria, ricordi confusi e nebbiosi che inconsciamente ha provato a rimuovere senza mai riuscirci del tutto.
Ci sono ancora tracce della sua vita a Wind Gap che non sono state sepolte dal tempo e che esercitano su di lei un forte richiamo. Cosi come le tracce che lei ha lasciato sul suo corpo, sulla propria pelle, parole incise nella carne delle braccia, delle gambe, sul seno, sull'addome, ogni punto del suo corpo è ricoperto di parole che pulsano e vibrano nella pelle comme fossero vive, sveglie:
"Il fatto è, vedete.. sono una che si taglia. O, se preferite, che si incide, si tagliuzza, si affetta, si pugnala. Sono un caso molto, molto speciale. Perchè ho uno scopo. La mia pelle, dovete sapere, urla. E' coperta di parole - , , , - come se un intagliatore alle prime armi avesse imparato il mestiere sulla mia carne."
Segni, cicatrici, crepe nella pelle, parole soffocate dentro per lungo tempo che cercano di emergere, di essere urlate fuori. Perchè quelle parole nascondono una verità che non può essere più taciuta, una rabbia interiore che non può essere più frenata.
Gillian Flynn, dopo il grande successo editoriale de L'amore bugiardo, confeziona un altro thriller dalla forte connotazione psicologica: gli omicidi efferati delle due bambine di Wind Gap diventano a loro volta gli indizi della presenza di un mostro ben più crudele e subdolo del vero killer, una mente perversa cresciuta nell'odio che contamina e ammorba coloro che non riconoscono il suo amore malato, anche perchè troppo giovani per farlo.
Ed è un male che indirettamente sembra infettare proprio loro, le ragazze più giovani, le adolescenti, troppo inclini ad atteggiamenti violenti e di prevaricazione sulle compagne più deboli e smaniose di potere, di sentirsi desiderate ed ammirate, di avere tutto e subito, senza remore e senza inibizioni, pur essendo ragazzine di soli 13 anni.
E la causa, la fonte del male, è nella famiglia, in un rapporto malsano e venefico tra madre e figlie.
"Un bambino svezzato con il veleno considera il dolore un conforto."
Indicazioni utili
"Faites vos jeux, s'il vous plait"
Dopo “L’anello mancante. Cinque indagini romane per Rocco Schiavone”, Antonio Manzini fa ritorno in libreria con “Fate il vostro gioco”, giallo che ci propone una nuova avventura del personaggio più famoso nato dalla sua penna e immaginazione; Rocco Schiavone.
Due coltellate, una all’altezza della giugulare e l’altra al fegato, hanno determinato la morte di Romano Favre, sessantenne pensionato ragioniere legato al casinò di Saint-Vincent per la sua attività di “ispettore di gioco”. Il ritrovamento ha avuto luogo per mano dei vicini di casa e più precisamente da parte di due vecchiette e da Arturo Michelini, croupier presso il casinò Saint-Vincent che, insospettiti dall’assenza di risposta da parte del contabile perfino di fronte alla fuga della sua amata gatta siamese chiamata Pallina, decidono di andare a verificarne lo stato di salute. Sangue, tanto sangue. Non vi sono dubbi sulle cause del decesso. Sul luogo intervengono Schiavone e la sua squadra che già dai primi rilievi si rendono conto che qualcosa nella ricostruzione dei fatti non torna. Basti pensare, in merito, a quel bic bianco rinvenuto sul comodino del defunto o ancora a quella fiche del casinò di Sanremo (perché di questo casinò e non del più vicino Saint-Vincent?) racchiusa nella sua mano. O ancora, basti pensare, a quella porta finestra lasciata misteriosamente aperta e a quella toppa della porta con al suo interno inserite le chiavi di casa. Tanti tasselli, questi, che non solo fanno capire a Schiavone di trovarsi di fronte ad “un morto che parla” ma che al contempo aprono la prospettiva su uno scenario ben più ampio, fatto di riciclaggio, di criminalità, di sotterfugi, di gioco d’azzardo, di ludopatia, di strozzinaggio, di usura e molto altro ancora. E seppur il vicequestore riesca ad arrivare alla conclusione e alla risoluzione del caso, le trame e le prospettive sono talmente intricate e ben articolate tra loro da rendere inevitabile il proseguo delle vicende proposte in un nuovo e separato capitolo. Da qui, il finale aperto sull’indagine e il sipario che definitivamente – e dolorosamente – scende su quel maledetto “7-7-2007”.
Quello che ci troviamo di fronte in questo nuovo capitolo delle avventure del romano esiliato vicequestore, è un testo con tutte le caratteristiche del giallo, è un testo con un ottimo intreccio narrativo, è un testo con un mistero che regge su tutta la linea e che è caratterizzato da un rapporto causa-effetto ben cadenzato e ritmato, ma è anche un testo in cui riscopriamo la figura di questo eclettico funzionario di polizia. Paradossalmente, infatti, si percepisce dalla sua voce la stanchezza di una vita fatta di dissoluzione e dolore, si percepisce la stanchezza di un lavoro usurante in prossimità dei cinquant’anni, si percepisce la nostalgia per quei tempi ormai andati che mai potranno fare ritorno. Il suo è un tono malinconico, molto più vicino ai romanzi noir che ai gialli veri e propri, se vogliamo. E forse questo è dovuto al fatto che Rocco, così come il suo vicino Italo Pierron, ancora non hanno superato il tradimento di Caterina, occorso in quel di “Pulvis et Umbra”. Tratti immancabili e che non mutano attengono invece all’indole rozza, schietta, smaliziata, cinica e ironica a cui siamo abituati sin dai primi episodi.
Un giallo che tiene bene nonostante questo non fosse semplice visto il grande successo e la meravigliosa riuscita proprio di “Pulvis et Umbra”, che ad oggi, insieme a “7-07-2007”, è sicuramente il capitolo meglio riuscito dell’intera saga. Non ci resta altro che aspettare il prossimo volume delle avventure di questo versatile personaggio.
«Pensavo che siamo come i serpenti. Ci lasciamo dietro la vecchia pelle perché abbiamo bisogno di quella nuova. Ma la vecchia pelle c’è stata. È un fatto, senza la vecchia pelle quella nuova non c’è» p. 378
«Che tu puoi essere qui e altrove, sei sempre tu e io sono sempre io. Tempo, spazio, non importa, Rocco. Quello che conta è che siamo qui. La differenza? A me certe cose non interessano più, a te sì. Ma il motiov lo conosci.» p. 380
«Lei sa come far credere che qualcosa sia vera? È semplice. Si dicono un sacco di verità comprovate e in mezzo, come un’insalata, si butta una cazzata che la gente prenderà per buona.» p. 388
Indicazioni utili
 Opinione inserita da Flavia Buldrini 22 Ottobre, 2018
Opinione inserita da Flavia Buldrini 22 Ottobre, 2018
Top 500 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Tutta un'altra storia
Ciò che Evelina Santangelo ci prospetta, ambientato nel prossimo futuro, in un non lontano 2020, è davvero un altro mondo, il quale si affaccia dagli occhi spauriti dei “bambini viventi”, la cui leggenda sconvolge e agita gli animi di una compassata Pianura Padana, come infestata dai fantasmi di quell’infanzia altra che non ha conosciuto altro che il dolore e la morte e mette in subbuglio la tranquilla ordinarietà scolastica, tra maestre e genitori spaventati e le Forze dell’Ordine in continua allerta. Inoltre, queste inquietanti suggestioni popolano la solitudine di un anziano vedovo soprannominato Orso che vive con il suo cane Lupo e sollevano la violenza cieca degli skhinead che danno alle fiamme un campo rom. Frattanto, si seguono a distanza due storie parallele che avranno epiloghi insospettati: un ragazzino, di nome Khaled, che attraversa dal Nord al Sud tutta l’Italia con un trolley rosso che non molla mai, che poi si svelerà in modo agghiacciante contenere il cadavere del fratello Nadir, morto tragicamente in un incidente sul lavoro, che il giovane vuole riconsegnare, dal porto di Palermo, alla sua terra e ai suoi cari; ciò in cui alla fine, nonostante tante traversie, riesce. Poi è il dramma angoscioso di Karolina a Bruxelles, la quale, per inseguire le tracce di suo figlio Andreas scomparso, irretito dalla propaganda jihadista, smarrisce progressivamente le coordinate della propria esistenza, fino a vederla frantumarsi in un’improvvisa detonazione davanti al Palazzo di vetro, ad opera di un attentatore, che si rivelerà essere un povero disperato, Omar, strumentalizzato ai fini della barbarie terroristica, che era stato anche amico di Khaled, aiutandolo a trovare il passaggio per la Sicilia, sfruttando proprio le sue conoscenze e risorse economiche ‘altolocate’. Ciò che si legge dietro le righe è, dunque, che, nonostante le notevoli disparità, tutte queste campionature umane sono accomunate da un’ontologica miseria, che è anche alla radice di ciò che finisce per ipostatizzarsi in strutture di male dietro cui si trincerano inconfessabili paure e debolezze. Inoltre, quello che all’esterno appare come indizio di chissà quale terrificante minaccia, in realtà è solo l’espressione della problematicità e della condizione di precarietà di ogni individuo. Il merito di uno scrittore è, infatti, quello di indagare, in controluce al “vero storico”, secondo l’incisiva definizione del Manzoni, il “vero poetico”, vale a dire la vicissitudine umana, intrisa di lacrime e sangue, che sottentra alla cinica aridità della cronaca.
Affiora, dunque, da queste pagine, attraverso un lucido visionarismo, un’umanità dolente e inerme, atterrita dalla propria stessa immagine che, proiettata sul grande schermo della Storia, assume sinistri riflessi di autodistruzione e di morte, amplificati dalla grancassa della fittizia ideologia che l’avalla, alla stregua di una maschera grottesca che cela la nuda verità che non si ha il coraggio di guardare in faccia.
Indicazioni utili
Il valore della libertà
Ci sono voluti quasi cinquant’anni prima che Tahar Ben Jelloun trovasse le parole giuste per raccontare la sua storia. Proprio lui, che, di storie, ne ha scritte una infinità, paradossalmente, non riusciva a scrivere la propria. Perché quella narrata ne “La punizione”, il nuovo romanzo dello scrittore marocchino nativo di Fes e residente da lungo tempo in Francia, è una vicenda che sa di memoria e profonda amarezza. Un viaggio a ritroso seguendo le pesanti orme del tempo, una rielaborazione dolorosa ma necessaria di quanto accaduto tanti anni fa per poter chiudere i conti con un passato che non è possibile cancellare né ignorare del tutto.
Era il marzo del 1965 quando gruppi di studenti universitari manifestarono pacificamente per le strade di Rabat e Casablanca; in quell’occasione, la repressione, piuttosto brutale, non si fece attendere. Tra quei ragazzi, c’era anche Tahar Ben Jelloun, all’epoca studente di filosofia. L’anno seguente, per lui e una novantina di altri giovani che erano stati segnalati, la “punizione” bussò alla porta di casa sotto forma di perentoria convocazione a presentarsi presso uno sperduto campo militare nelle vicinanze della città di Meknès, nel nord del Paese. Era l’epoca in cui molta gente spariva all’improvviso, inghiottita dalla cieca violenza del regime dell’allora sovrano Hassan II, e si viveva in un continuo clima di paura; esercito e polizia, avendo carta bianca, facevano ricorso a qualunque mezzo pur di reprimere ogni possibile dissenso. La monarchia ’alawide offriva il volto forse peggiore di tutta la sua storia.
“Cosa abbiamo fatto di così grave? Organizzarci legalmente, manifestare pacificamente, reclamare libertà e rispetto.”
Per tutta risposta, vennero spediti anzitutto al campo militare di El Hajeb, dove ebbe così inizio un vero e proprio internamento, il cui scopo ufficiale era quello di rieducarli e insegnar loro a diventare bravi cittadini, all’insegna del vecchio e abusato slogan “Allah, al-watan, al-malik” (“Dio, la patria, il re”) che ancora oggi si vede scritto a grandi caratteri e disseminato qua e là per il Marocco. A scandire le lunghe giornate in quel luogo poco ameno si susseguivano maltrattamenti, umiliazioni, privazioni di ogni genere alla completa mercé di comandanti militari semianalfabeti, psicopatici e privi di scrupoli, spesso in preda a delirio di onnipotenza.
Picchiati, denutriti, sporchi e infreddoliti, con i capelli costantemente rasati a zero, i “puniti” venivano tenuti nel più totale isolamento, senza che le rispettive famiglie sapessero ciò che in realtà accadeva; per di più, perdere la vita per il minimo accenno di ribellione o a causa di pericolose simulazioni di operazioni di guerra (non mancavano, infatti, le tensioni con la vicina Algeria) rischiava di essere tutt’altro che improbabile. Il giovane Tahar trascorse oltre un anno e mezzo in quello stato di detenzione, mentre a sostenerlo accorrevano, per fortuna, la tenacia della sua poesia, il profondo amore per la letteratura e, da grande appassionato di cinema quale era, la magia delle immagini dei film che amava, come quelle di Charlie Chaplin nei panni di Charlot.
“[…] di fronte alla sensibilità, alla intelligenza, il potere oppone la brutalità e la stupidità. La prima arma è l’umiliazione, questa violenza che consiste nel declassarci, nel metterci sull’orlo del baratro minacciandoci di darci un calcio nella pancia. Mi aggrappo ai ricordi delle mie letture; non so se recito fedelmente ciò che ho letto o invento delle frasi. Ho in mente Dostoevskij, ?echov, Kafka, Victor Hugo… […] Nella mia testa sfilano scene dai film di Charlie Chaplin. Perché il bravo Charlot viene a trovarmi in questa terra ingrata e macchiata da militari abietti? Ne rido di nascosto […] Quell’omino che riesce a ridicolizzare i violenti che lo perseguitano mi ossessiona. Quel genio ha vendicato milioni di umiliati nel mondo. Ecco, questa era la sua missione, il suo disegno. Grazie, Charlot.”
Poi, inattesa e quasi irreale, la fine della prigionia, anche se le sue catene sembravano trascinarsi pure nella vita civile (“Sono stato liberato ma non sono libero.”). La vera liberazione, non a caso, arriverà soltanto diverso tempo dopo e a seguito di un evento davvero sorprendente e imprevedibile…
Una prosa che cattura fin dalle prime battute, appassionante ed estremamente fluida per un romanzo che si fa testimonianza diretta, viva, palpitante e che riconferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, le straordinarie doti di narratore di Tahar Ben Jelloun, nome tra i più noti e apprezzati sulla scena letteraria internazionale. Il suo linguaggio semplice e chiaro che si propone con garbo, le sue denunce, i suoi messaggi di pace e tolleranza religiosa (a tal proposito, invito a leggere le bellissime e istruttive pagine del breve saggio “L’Islam spiegato ai nostri figli”, Bompiani, 2001), il suo chiamare tutto col proprio nome e raccontare le cose così come stanno senza edulcorazioni di sorta fanno di lui un autore particolarmente interessante da seguire. Quest’ultimo suo lavoro, nello specifico, come spesso accade in molte opere della vastissima produzione di Ben Jelloun, punta l’attenzione su un Paese, il Marocco, dietro la cui immagine patinata di meta turistica più o meno a buon mercato persistono problemi assai gravi, quali tortura per dissenso politico, sempre mal tollerato dalle autorità, e corruzione abnorme che rallenta l’apparato burocratico e calpesta i diritti dei cittadini, sebbene sotto l’attuale sovrano Mohammed VI, non certo temuto come il terribile padre Hassan II, siano stati realizzati importanti ma non ancora sufficienti cambiamenti.
Infine, un romanzo che, attraverso la vicenda personale del suo autore, ci parla del valore della libertà, di quanto essa sia preziosa per la nostra dignità di esseri umani e di come, talvolta, basti davvero poco per perderla.
“Sarei potuto uscire dal campo cambiato, indurito, adepto della forza e anche della violenza, ma sono uscito com’ero entrato, pieno di illusioni e tenerezza per l’umanità. So che mi sbaglio. Ma senza quella prova e quelle ingiustizie non avrei mai potuto scrivere.”
Indicazioni utili
Ma non necessariamente, nel senso che ci si potrebbe accostare a questo autore anche iniziando da questo romanzo.
Gradisci un Bartleby?
"Non è semplice diventare uno spettatore" scrive Daniel Pennac nel suo ultimo libro, "Mio fratello". Pennac si riferisce al teatro, ma forse implicitamente anche alla vita: non è facile stare a guardare la vita, nel su bene e nel suo male.
"Mio fratello" è un brillante racconto divisi in tre macrotemi perfettamente alternati:
1. L'adattamento teatrale che Pennac ha portato in scena, pochi mesi dopo la morte del fratello Bernard, del "Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street" di Melville: opera riadattata in una lettura per un singolo interprete - Pennac stesso - e raccontata seguendo il flusso di pensieri del notaio che assume il famoso Bartleby.
2. Le "reazioni" del pubblico in sala. Dall'inizio alla fine, seguendo il ritmo della storia, Pennac analizza e sorride ai suoi spettatori: è uno spaccato molto bello dell'atmosfera che si respira a teatro, del pubblico che si immerge a tal punto nella storia da non riuscire a staccarcisi una volta usciti dallo spettacolo.
3. I ricordi, "che erano sensazioni", del fratello Bernard, della vita passata insieme, soprattutto delle cose dette - pochissime - e delle cose non dette - talmente tante da chiedersi "chi ho perso?".
Il filo rosso che unisce queste anime è proprio il personaggio di Bartleby, tanto particolare quanto impossibile da non amare: protagonista della piece teatrale, il preferito dai fratelli Pennac, tanto simile proprio a Bernard e quindi idea da portare in scena per una sorta di "continuità": portando in scena Bartleby Pennac sta ancora parlando con il fratello. La somiglianza tra i due appare sempre più chiara man mano si prosegue la lettura, e arrivarci così piano, accarezzando quasi i due uomini, penso sia la perla più bella dell'autore.
Soprattutto perché Pennac riconosce di parlare di un fratello che conosceva ma forse no: del quale ricorda alla perfezione gesti e sfumature, ma con cui non ha mai condiviso segreti, confessioni. Un fratello che ha vissuto la propria solitudine in silenzio, senza disturbare, lasciandosi dare l'etichetta più comoda per gli altri.
Devo ammettere che mi sono avvicinata a questo libro, per la sua peculiare composizione, un po' scettica. Nel giro di poche pagine mi sono ricreduta: lo stile brillante e al contempo delicato di Daniel Pennac trasporta in una storia di profondo amore tra fratelli, mai pienamente espresso. E insieme la storia dell'"umanità", con gli schemi e le domande e le curiosità da soddisfare sempre.
Mentre a volte "fin dall'inizio non succede quasi niente e non succederà più niente fino alla fine." E questa è la vita.
Indicazioni utili
Top 50 Opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
Le piccole mani
“Dove sono andato, Noemi?” - una vocetta nei sogni - “Vuoi veramente saperlo? Preparati che sto per dirti una cosa bella: è successo una mattina, sentivo le ali forti forti, così ho provato ad alzarmi in volo. E ho volato, io volavo! E sono volato su, più su, nel cielo dove riuscivo a vedere il giardino, il tetto, la strada, le cave. E dall’alto, io vi guardo sempre dall’alto Noemi, continuo a guardarvi, non dimenticarlo, quella mattina io vedevo voi, piccoli, che mi cercavate.”
Noemi, 9 anni, mani troppo piccole per stringerne altre ancor più piccole, mentre la calca aumenta, mentre mamma è più avanti, impegnata ad inseguire fotografi cui esibire il suo bambino. E’ così che Andrea perde la stretta della piccola sorella. O forse è Noemi a non essere capace di tenerlo a sé.
Passano i giorni, tra le ricerche della polizia, le domande dei giornalisti, i falsi avvistamenti, i gesti di solidarietà, le chiacchiere malevole, l’affievolirsi dell’interesse… Passano gli anni di Noemi, tra la fragilità di sua madre, l’adolescenza, la voglia di fuggire in città, la morte di suo padre, infarto fulminante, l’università, l’incontro con Davide.
Noemi è matura. Determinata a non subire alcun senso di colpa. E’ forte, a suo modo, Noemi. E così non dimentica, non rimuove: non si assopisce, in lei, il desiderio di sapere, e quello – diverso – di comprendere, attraverso i ricordi della bambina e le capacità della donna.
Comprendere, prima di ogni cosa, chi sono – realmente e senza finzioni – i familiari attorno ai quali si è dipanato l’infelice evento, e quel che è venuto dopo…
Ci sono romanzi nei quali il come (raccontare una vicenda) rappresenta, per l’autore, una sfida più affascinante rispetto al cosa, alla vicenda stessa.
“Matrigna”, di Teresa Ciabatti, gira secondo il moto di gravitazione di un pianeta sul proprio asse: in modo regolare, progressivo, immodificabile, alcune zone del racconto vengono alla luce, mentre altre tornano in ombra. Zone che corrispondono ad altrettanti personaggi. Sono, fino agli ultimi capitoli del libro, quasi esclusivamente personaggi femminili – Noemi, sua madre, sua zia –, mentre quelli maschili restano in disparte, esistenti più che altro nei ricordi (tristi), nelle preghiere, nelle invocazioni, nei rimpianti. Se ne distaccano Davide e Luca, figure in certo modo parallele: punti di riferimento, il primo per Noemi, il secondo per sua madre. Ma la ragazza, grata a Davide, non può esserlo a Luca, del quale comincia a diffidare: troppo giovane (rispetto alla madre), troppo sfuggente… E’ da qui, da qualcosa che succede molto tempo dopo la scomparsa del fratello, che imprevedibilmente nascono i presupposti per “risolvere” il mistero.
Non il racconto di un evento-limite dunque, ma qualcosa di più complesso: lo sguardo soggettivo su un evento-limite e sul modo in cui le vite scorrono attorno a (ed in memoria di) esso.
Indicazioni utili
Esercizi d'inesistenza
Esercizi d'inesistenza. É questo ciò che ogni giorno prova a fare Leone, un bambino di soli sei anni, che ha da pochi mesi iniziato a frequentare la prima elementare. I suoi genitori sono separati e Leone vede il padre un venerdì ogni quindici giorni, per andare a cena in un anonimo Fast food e non dirsi niente, non avere un minimo scambio di sentimenti e neppure di comunicazione quotidiana. Con la madre Katia invece, Leone convive e quindi con lei esiste una relazione basata su momenti di vita vissuta insieme: anche se sono pochi e caratterizzati dalla fretta. La mamma di Leone è una donna sola, lasciata dal marito dopo solo un anno di matrimonio, non può contare sulla presenza di una famiglia d'origine perché aveva solo la madre, che è morta sei mesi prima. L'assenza della nonna pesa come un macigno sull'esistenza di Leone e su quella di Katia, il dolore causato dalla perdita e dal lutto viene negato, soffocato e quasi nascosto, come se i due in qualche modo se ne dovessero vergognare: non ne parlano apertamente l'uno con l'altra. Katia è profondamente triste, vive immersa nella sua solitudine, sopraffatta dagli innumerevoli impegni quotidiani; non sa e non riesce a comunicare con il proprio figlio.
Ciò che emerge dalla lettura dell'ultimo romanzo di Paola Mastrocola è il ritratto di una società, la nostra, che appare come un luogo malsano e malinconico: una somma di individui che rimangono tutti ben separati e distanti; ciascuno irrimediabilmente solo e triste, chiuso nella propria stanchezza e superficialità. Il quadro che esce tratteggiato dalla penna esperta dell'autrice è abbastanza desolato: un insieme di persone che non crede più in niente, che non è in grado di trovare uno scopo e di dare un valore profondo alla propria esistenza. Ci si accontenta di vivere seguendo lo stimolo di un'emozione o di una sensazione, come una nave che si disperde per il mare senza una meta da raggiungere.
Il piccolo Leone viene ad un certo punto bullizzato e deriso dai suoi compagni. I suoi genitori, la madre in particolare, si vergognano di ciò che sta facendo, lo rimproverano, iniziano seriamente a preoccuparsi. Volete sapere perché? Qual è l'atroce problema? Leone prega. Ha avuto un'educazione cristiana, sebbene la madre non ne abbia mai saputo nulla, dalla nonna, che è morta da pochi mesi. (E anche questo fa riflettere su quanto la nonna e la madre di Leone comunicassero tra loro). Insomma, il bambino crede a Gesù, lo prega e questo scatena una serie di problemi.
Mi sembra evidente quindi come il romanzo voglia denunciare una forte crisi di valori che senza dubbio caratterizza la nostra società. Non si può rimanere indifferenti di fronte a questo: una società che isola e ridicolizza un bambino perché prega? Ma che tipo di persone possono essere delle persone che fanno una cosa del genere? Degli esseri umani che non credono più in niente, che hanno rinunciato alla speranza, vuoti, e che vivono una vita senza senso: non ci si stupisce più di constatare quanto dolore, tristezza e solitudine animino le loro esistenze.
Il romanzo è caratterizzato da una narrazione che inizia come realistica ma a poco a poco e in modo sempre più marcato, diventa allegorica. Gli ultimi tre capitoli in particolare mi hanno lasciata spiazzata, intrisi di un realismo magico che trasforma la trama in una metafora. Non sono sicura di essere riuscita ad apprezzare pienamente questo finale.
In conclusione quindi, leggendo “Leone” abbiamo la possibilità di riflettere su quanto la vita di molte persone di oggi sia permeata da una dolorosa solitudine e di interrogarci sul perché avvenga questo. É una storia apparentemente semplice ma in realtà fortemente allegorica: una lettura che può soddisfare anche il lettore più esigente. Mi rimane solo un dubbio sulla scelta stilistica dell'autrice nel finale, ma naturalmente, si tratta solo della mia opinione personale.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 20 Ottobre, 2018
Opinione inserita da ornella donna 20 Ottobre, 2018
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
La giovane somala Sahra
Le rughe del sorriso di Carmine Abate è il titolo del suo ultimo, sentimentale e toccante, libro. Racconta, con metodo e disincanto, una storia dei giorni nostri, di grande attualità. Una storia scritta che incanta e stupisce, con drammatica consapevolezza, che conduce il lettore all’interno di uno dei problemi più discussi e complessi del tempo: l’immigrazione dell’Africa verso l’Italia.
L’autore racconta, infatti, la storia di Sahra, una giovane somala che con la cognata Faaduma e la nipotina, vivono all’interno di un centro di accoglienza in Calabria. A narrare di loro è il giovane insegnante d’italiano, Antonio Cerasa, che in quel centro vi lavora. Sahra è:
“Sahra era di una bellezza speciale, a incignare dall’occhi e dalla bocca che appena li quadravi ti fulminavano in un sorriso lampante, zuccherino come un fico nivurello. Per non parlare della restante nascosta sotto la veste larga e colorata, che ti metteva allegritudine quando la miravi. (…) No, non lo sapevamo che Sahra era studiata , non si dava tante arie, sembrava una di noi, solo più nivura, più alta e più bella.”
E’ una giovane di rara bellezza, di grande fascino, elegante ed educata. Il suo sorriso è:
“no, non era un sorriso di compiacimento. A volte sorrideva solo con la bocca, mostrando i denti bianchi e forti, una sensualità inconsapevole che attizzava la voglia di baciarla, mentre i suoi occhi non cambiavano espressione, inseguivano traiettorie enigmatiche, che nessuno di noi poteva intercettare perché nessuno aveva vissuto il suo dolore.”
Finchè un giorno scompare nel nulla. E’ un mistero che addolora, di cui nessuno si capacita, ma lei:
“della sua vita non amava parlare con nessuno. Alle mie domande rispondeva gentile ma in maniera sintetica o evasiva, cosicchè di lei conoscevo poche storie frammentarie, per giunta sfocate. I suoi segreti se li teneva annodati dentro un fazzoletto di cotone e in fondo alle pupille nere nere, scintillanti.”
Non resta che al giovane insegnante, segretamente innamorato di lei, di ricostruire la sua storia, la sua vita, i suoi dolori. Non sarà sempre facile: si parte dal villaggio somale di Ayuub a Mogadiscio, per passare nell’inferno delle carceri libanesi, passando poi per il Trentino e giungere in Calabria. Sarà così che questa assenza si tramuterà in presenza lieve e costante, eterea, nella vita del giovane, fino alla sua naturale conclusione.
Un libro scritto con una prosa precisa ed attenta, poetica che incanta. Bellissime le pagine, ad esempio, dedicate alla narrazione di quando Sahra vede per la prima volta la neve in Trentino:
“L’unica cosa che non poteva immaginare, pur avendola vista in decine di foto, fu la neve, la sua magia, piccole piume che cadevano dal cielo, e formavano un manto bianco luccicante di cristalli, soffocando ogni rumore. (…) I fiocchi di neve le sciamavano attorno come miriadi di piccole farfalle bianche, poi le si posavano sena peso sulla faccia, sul velo, sulle mani.”
A fare da contraltare a tanta magia le pagine in cui l’autore descrive la situazione immigrati, la piaga del caporalato:
“ragionavano coi paraocchi, sulla base dei pregiudizi, per sentito dire. (…) I migranti ci ricordavano troppo chi eravamo fino a ieri e molti lo volevano dimenticare, prendendosela con persone senza alcuna colpa, se non quella di avere un destino peggiore del nostro.
Migliaia di braccianti stranieri vivevano ancora ammassati in dormitori di fortuna, una parte di loro per tutto l’anno, circondati da cumuli di spazzatura, sfruttati di giorno da padroni, caporali e capineri. “
Un libro toccante e sentimentale, che non giudica mai, che guarda con disincanto ad un problema difficile ed ostico, privo di artefici ideologici, moralismi e quant’altro. Lasciando una finestra aperta sulla bellezza del vivere quotidiano poiché:
“tutte le verità di questa storia, di cui ancora ignoravo il finale, tutte le sofferenze e le gioie dei protagonisti, il loro passato e il sogno del futuro, persino la crudeltà dei nostri mondi, parevano custoditi nelle rughe del sorriso di Sahra, come in uno scrigno segreto. “.
Indicazioni utili
 Opinione inserita da ornella donna 17 Ottobre, 2018
Opinione inserita da ornella donna 17 Ottobre, 2018
Top 10 opinionisti - Guarda tutte le mie opinioni
un uomo decadente e cattivo!
Il precedente Bruciare tutto di Walter Siti era uno “scandalo mancato” nel senso che se ne era discusso per motivi di costume, senza che il contenuto pedofilo influisse più di tanto nella vendita. Ora torna con Bontà, un racconto lungo che del titolo non ha nulla, perlomeno nei contenuti. Al contrario è un testo sulla cattiveria. Di cui, nonostante la brevità, non solo ho faticato a leggere, ma anche a concluderlo. Intendiamoci i temi cari allo scrittore ci sono tutti: la letteratura, i libri, l’omosessualità, il matrimonio civile, la sofferenza, il decadimento, la vecchiaia. E’ lo stile di scrittura, il contenuto stesso del libro che non mi ha convinto per nulla.
E’ la storia di Ugo, un uomo anziano, che ha avuto successo nell’editoria, ora cinico e disilluso, e guarda al mondo con disprezzo e malvagità. Nulla si salva, neppure, ad esempio, il volontariato, perché pensa che:
“chi esagera coi gesti gentili, pensa Ugo, non ha le unghie abbastanza forti per graffiare; è come quelli che si dedicano al volontariato per sentirsi meglio loro. Le schitarrate per i diritti umani, la solidarietà per guadagnare punti agli occhi di Dio, la carità come nevrosi, l’altruismo da fiera e da salotto. Ugo odia il cameratismo, preferisce essere rispettato che venvoluto.”
Non parliamo poi degli scrittori, definiti:
“Il fallimento come scrittori in proprio è il tumore inconfessabile di molti editor; per una sorta di gentlement l’argomento è tabù, cane non mangia cane. Qualcuno ce la fa, pubblica i propri libri presso case editrici concorrenti, pochissimi hanno il coraggio di auto pubblicarsi sfidando il conflitto di interessi-in ogni caso, mescolare i due livelli in pubblico è considerato impudico.”
La letteratura non può che essere un totale fallimento, facile preda delle inutili e vuote logiche di mercato:
“I romanzi sui bambini malati di cancro, sulle donne aviatrici nella Seconda guerra mondiale, sui migranti che ripopolano paesi fantasma, (…) sui trentenni frustrati che riscoprono la natura vergine, sui giornalisti eroi e le camorriste riscattate dalla maternità, sulle paturnie sentimentali del ceto medio purchè finisca bene. Tutto scritto alla carlona, emotività confusa e onanistica, con errori di sintassi e di grammatica e di orecchio. Se la parola ha dato senso al mondo (…) ora la sciatteria della parola serve per restituire il mondo alla sua insensatezza. E i polizieschi, che dio li strafulmini, e i noir anzi i polar; te lo dicono proprio in faccia, “ciò messo dentro un delitto per dare vivacità al plot”, oppure “gli omicidi sono un pretesto per descrivere l’ambiente”. (…) Se nella società cova voglia di morte, per favore, non fabbricateci sopra il nostro intrattenimento. (…) Se la prende col diluvio di troppi titoli, (..): gigantesca autoipnosi di massa, che nasconde la realtà.”
Ugo è molto ricco di famiglia, anche se figlio della guerra, perché nato nel 1944, per cui:
“è ricco grazie alla madre, vedova in successione di due uomini che per l’Italia hanno contato qualcosa (ma nessuno dei due gli è stato padre).”
Abituato a fare del male, non accetta la decadenza, e l’umiliazione che ad essa si accompagna, allora decide di stupire ancora una volta, e sposarsi con Manuel, con un’unione civile. Manuel è molto più giovane di lui, un adone greco che del consorte apprezza solo il vil denaro. E proprio attraverso un falso amore e un suicidio per procura che il protagonista cerca di trovare l’immortalità, di superare i propri limiti per raggiungere, forse, la pace, una forma di riscatto, mai trovata in vita.
Definito nella quarta di copertina come:
“in questo romanzo ironico ed impietoso, lo spirito di una civiltà in agonia è incarnato da un vecchio cinico, deciso –come un eroe tragico o solo stanco- ad annullarsi cercando la morte nell’amore”,
il libro e la sua lettura non mi ha convinto. Morboso nel linguaggio, spesso incomprensibile nei contenuti e nel loro significato, il testo si è rivelato una lettura pesante e poco accattivante. Se, però, si ha molto tempo e, soprattutto, costanza, ad un’analisi più dettagliata e minuziosa si rivela ricco di spunti di riflessione e di discussione per quei temi trattati, come detto all’inizio. Volendo, appunto, salvare qualcosa. Ma è uno sforzo immane.
Indicazioni utili
Questa notte è irreparabile
Una sera d'inverno, a cena, Erri invita alla sua tavola il figlio che non ha mai avuto, da quella donna che decise di abortire...
Un figlio già adulto, che gli farà dono di una paternità inesistente e darà inizio ad un dialogo tra un uomo che non è mai stato padre ed un figlio che non è mai nato, un figlio senza infanzia, senza giochi e senza febbri.
Geppetto forgia il suo bambino con il legno, lui lo fa con quello che sa usare meglio...le parole.
Quelle parole che gli hanno permesso di dare concretezza al suo mondo, di non farlo sentire solo "una persona d'aria", inconsistente, svaporata.
Ha inizio così una sorta di confessione, un bilancio di vita, quasi un testamento...
Lo scrittore ripercorre la sua "vita scivolata", la sua infanzia in una Napoli che accetta i vizi ma non il ridicolo e la goffaggine, ricorda la durezza di sua madre, le arrampicate con il padre, i primi baci, la voglia di andare via, la militanza politica, i libri letti e quelli scritti, le paure represse, il coraggio imitato, il rapporto con le parole, con la fede, con l'amore in quanto "ossigeno", con il proprio corpo...
"Ho un corpo e sono stato al gioco di viverci dentro"
Quale gioco?...il gioco dell'oca.
Un gioco di percorso in cui si lancia un dado e ci si sposta nelle varie stazioni.
Un gioco in cui la vera libertà è quella di scegliere se lanciare o meno...
Il tavolo apparecchiato per due di questa sera è la sua ultima casella.
Vuole fermarsi e lasciare il lancio a lui, a questo figlio assente che pian piano prende forma...
Ma il suo non è un'interlocutore muto, è un figlio che risponde, che mette tutto in discussione, che contraddice.
È la sua coscienza, il suo grillo parlante, è lo specchio in cui non si vuole riflettere.
È il figlio di una sola notte che sceglie di non prendere il testimone della sua vita, che preferisce sparire nel nulla letterario da cui è nato...
"Capolinea, papà, siamo arrivati.
Non esco, rientro. Ritorno nel tuo spazio, dal quale sono uscito perché mi hai fatto posto.
Rientro nel tuo corpo.
Guarda la mia mano, si avvicina alla tua.
Ecco il braccio e il resto di me stesso che si riassorbe in te.
Ci sono quasi, mancano solo gli occhi.
Chiudili, per favore."
Un libro intimo, poetico, dall'atmosfera lieve e rarefatta...un'ipotetica gara a chi esiste di meno.
Una notte senza contorni, che nasce dal silenzio umano e prende forma in un racconto che non c'è, una notte che non si può toccare e che non resta, ma che non si può dimenticare.
"Questa notte non potrà essere tolta dal registro delle notti, fare che non sia accaduta.
È senza rimedio, come ogni azione commessa.
Questa notte è irreparabile."
Indicazioni utili
TRA LAVORO E SOGNI
Suite 405 è il nuovo romanzo di una delle penne più amate della narrativa contemporanea, Sveva Casati Modignani.
Dopo averlo finito ho pensato: finalmente Sveva è tornata ad emozionarmi come lo aveva fatto anni fa, ho sicuramente letto una storia molto attuale e interessante e la sua scrittura semplice dell’autrice mi ha conquistata.
Il libro ha come protagonisti Lamberto Rissotto, imprenditore di succcesso e Giovanni Rancati sindacalista convinto e molto appassionato della sua professione, che lui vive come una “missione”.
Dire che i personaggi principali sono solamente due sarebbe riduttivo, ma diciamo che le vicende girano intorno a questi due uomini che sono molto diversi tra di loro ma che alla fine scoprono di avere molti punti in comune.
Lamberto potrebbe sembrare un imprenditore tutto d’un pezzo, fiero del suo successo, degli affari, spavaldo e pieno di sè ma invece tiene molto ai suoi dipendenti e cerca di migliorare la loro condizione.
La crisi economica dei nostri giorni è presente in maniera molto decisa nel testo e questo ha dato alla storia un punto in più, anche per come l’autrice è riuscita a parlare di questo argomento, in maniera assolutamente realista e non scendendo nel lato sentimentale.
Giovanni è un uomo che si è fatto da solo, ha fatto moltissimi sacrifici per la sua famiglia, ha dovuto rinunciare alle sue aspirazioni personali, purtroppo per lui i sogni sono rimasti tali. Con il suo lavoro, però, si sente utile e sta facendo qualcosa di buono per i lavoratori in difficoltà.
Oltre alla loro storia ci sono dei capitoli dedicati ad alcuni personaggi, il primo è per Armanda la moglie di Lamberto che scompare nei primi capitoli, poi tocca anche a Bruna, la fidanzata di Giovanni e a Chiara amica di Bruna.
Bruna è la fidanzata di Giovanni, fa la parrucchiera e nonostante un matrimonio fallito alle spalle ora è riuscita a ricominciare e ad aprire un proprio negozio. E’ una ragazza dolce e sensibile ma anche molto pratica, conosce da una vita Giovanni ma i due non sono mai riusciti a dichiarare i loro sentimenti l’uno per l’altra. O almeno fino a ora.
Chiara Montini è amica e cliente di Bruna, una ragazza che tira avanti facendo dei lavoretti santuari perché la libreria dove lavorava ha chiuso. Anche qui troviamo una situazione famigliare difficile, ma come spesso ci capita di leggere in queste pagine l’autrice descrive solamente delle situazioni di normalità.
Oggi il lavoro indeterminato non esiste più, siamo in balia delle aziende che sfruttano i lavoratori (la maggior parte) e non dico solo i giovani ma ormai a tutte le età succede questo.
La precarietà e la disoccupazione di certo non fanno vivere bene le persone, questo è un gran problema e alcune volte trascorriamo anni in questo stato, non sapendo se domani avremo ancora il lavoro.
I personaggi sono molto approfonditi e attraverso loro possiamo capire cosa si prova quando una persona è in questa situazione economica molto incerta. Posso dire che per la mia esperienza, trovarsi non per colpa nostra senza lavoro è terribile e ci vuole tanta forza per ricominciare e anche accettare di accontentarsi di quello che troviamo, anche se non è in linea con le nostre passioni.
Ecco noi oggi ci dobbiamo accontentare e farci andare bene tutto? Certo che no, ma si possono comunque coltivare i nostri interessi, anzi lo dobbiamo fare.
Trovare un lavoro che piace oggi è veramente un lusso. E un po’ anche il messaggio del libro, i sogni purtroppo per molte persone rimangono solamente sogni o aspirazioni, ma il segreto è reinventarsi oppure aspettare e avere fiducia perchè che prima o poi le cose belle accadono.
In questo romanzo abbiamo due punti di vista: da una parte l’imprenditore Lamberto e dall’altra Giovanni e tutti gli altri dipendenti e per una volta capo e lavoratori riescono ad andare d’accordo e a trovare un punto d’incontro . Anche se questo oggi è molto difficile da realizzare.
I primi capitoli non mi hanno convinta del tutto,ma poi la storia è decollata e mi sono affezionata in particolare a Giovanni, Bruna e Chiara.
Ho trovato che quello che abbiamo letto sia all’ottanta per cento verosimile e vicino alla realtà, alla nostra vita di tutti i giorni ma credo che alcune parte siano state romanzate. Soprattutto quella finale. E questo mi è dispiaciuto.
I capitoli dedicati alla vita di alcuni personaggi si alternano alla narrazione della storia ai giorni nostri, che ho trovato più convincente e appassionante.
Quello che non riesco a capire è come mai le case editrici si ostinano a stampare libri con moltissime pagine bianche e con caratteri molto grandi. Lo trovo solamente uno spreco.
Il romanzo è stata una sorpresa, ero rimasta delusa dagli ultimi libri di Sveva e speravo di leggere una storia che mi avrebbe appassionato, forte e intensa e in parte è stato così.
Ho apprezzato il realismo, la verosimiglianza dei personaggi e la grande ricerca che c’è stata dietro alla costruzione di questa storia, toccando dei temi forti e attuali ma che in fondo rappresentano il mondo in cui viviamo.
In tutto questo sicuramente ci sono dei punti deboli, alcuni parti risultano molto lunghe e discostano in parte dalla filo conduttore del libro, alcuni passaggi sono romanzati e prevedibili.
Non mi sento tuttavia di dare un giudizio negativo perché la storia mi ha coinvolto e fatto riflettere e perché le vicende di alcuni personaggi mi hanno appassionata.
Indicazioni utili
Dallo Space Invaders alla rivoluzione digitale
«[…] In vent’anni la rivoluzione è andata ad annidarsi nella normalità – nei gesti semplici, nella vita quotidiana, nella nostra gestione di desideri e paure. A quel livello di penetrazione, negarne l’esistenza è da idioti ma anche presentarla come una metamorfosi imposta dall’alto e dalle forze del male inizia a diventare piuttosto arduo. Di fatto, ci rendiamo conto che nelle consuetudini più elementari del nostro vivere quotidiano ci muoviamo con mosse fisiche e mentali che solo vent’anni fa avremmo a mala pena accettato in nuove generazioni di cui non capivamo il senso e denunciavamo il degrado. Cosa è successo? Siamo stati conquistati? Qualcuno ci ha imposto un modello di vita che non ci appartiene?» p. 14
Username. Password. Play. Maps. Level Up. Rivoluzione. La rivoluzione digitale. Com’è nata? Perché è nata? Cosa l’ha determinata? Ne siamo stati sopraffatti? Oppure semplicemente ci siamo trovati coinvolti in un vortice di nessi causali e concause che ci hanno assorbito senza che nemmeno ce ne rendessimo conto? Se guardiamo al passato, un passato poi nemmeno così lontano, fatichiamo ad immaginare le nostre giornate, fatichiamo a ricordare quel che eravamo, chi eravamo. Una vita senza app, senza social, senza foto, senza selfie, senza pc oppure con pc destinati esclusivamente all’uso lavorativo, una vita, cioè fatta di altro, di altre priorità. -“Ma davvero abbiamo vissuto così per decenni, per secoli?”- viene quasi spontaneo chiedersi. Sembra impossibile, eppure è così. Space invaders, i primi Commodore 64, i primi mac, windows 95 e la sua destabilizzante impostazione, internet e il word wide web (che badate bene, sono due cose ben diverse), gli mp3, i jpeg, gli mpeg, Mosaic, Cadabra, che non ci dice nulla all’apparenza, ma in realtà altro non è che la prima forma rudimentale del più noto Amazon ed ancora google, yahoo! – che hanno dato inizio alla sagra dei nomi scemi – ed ancora gli smartphone, la mela della apple, facebook, twitter, instagram, youtube, a wikipedia che “tutto” spiega, e ancora e ancora fino ad arrivare alle Alpha Go: la rivoluzione digitale. Una rivoluzione che nasce in tre gesti lunghi che tracciano un nuovo campo da gioco. E più precisamente, un primo che vede la luce con la digitalizzazione dei testi, dei suoi e delle immagini riducendo allo stato liquido il tessuto del mondo, un secondo che vede la realizzazione dei personal computer che non hanno più dimensioni gigantesche e/o funzioni prettamente militari perché ciascuno può avere la propria “scrivania” con il proprio “topo” in movimento per gestire i “cassetti” che, nella terza fase, sono tutti messi in comunicazione affinché ciascuno possa accedere a un cassetto dopo l’altro senza limiti, al cassetto dell’altro, senza remore, senza difficoltà. Una rivoluzione che ha portato alla spersonalizzazione e alla frammentazione, ma anche alla perdita di valori e alla perdita di confronto con il reale. Perché filtri e elementi digitali si mettono in conflitto con quella che sarebbe l’esistenza quotidiana creando e dando vita ad un mondo dove vincere è facile perché non c’è confronto. Il risultato è quello della creazione di individui inadatti alla lotta, incapaci di reagire alle difficoltà, nonché individui che fanno della superficialità i nuovi valori e dei vecchi un qualcosa di obsoleto, deprecabile, inutile. Quasi se ne fossero scordati. E siamo parte del “game”, un luogo che è strategia, un luogo in cui la strategia ha funzionato, un luogo a cui ci siamo talmente abituati che pensare a un risultato diverso da quello raggiunto ci fa storcere il naso, il luogo del tutto e subito e del non guadagnato perché ci spetta “di diritto”.
Con “The game” Alessandro Baricco ricostruisce la spina dorsale di questa rivoluzione digitale che ci ha coinvolto e che ci sta coinvolgendo. Il suo è un percorso che va per tappe, per “epoche”. Ci prende per mano, il narratore, ci ricorda degli anni del calciobalilla, dei flipper e dei rudimentali videogiochi in quella che era la dimensione analogica e ci conduce a quella che è l’era digitale dove l’icona dell’uomo-spada-cavallo viene sostituita dall’icona dell’uomo-tastiera-schermo. Questa è la prospettiva attuale di quel sisma rivoluzionario che è riuscito a mutare interamente la postura di noi umani partendo dalla dimensione più intima: la mente. Perché è in questa che la rivoluzione è stata innescata e che tutt’ora è in una corsa costante senza freni e tempo. E non è stato un processo imposto, bensì un qualcosa che abbiamo scelto, accettato poco alla volta, senza quasi rendercene conto tanto da sfuggirci quasi di mano. Una rivoluzione che probabilmente nemmeno i pionieri della stessa avevano così pensato. Probabilmente alla base vi era l’idea del progresso, di evitare che nuovamente le tragedie del Novecento potessero ripresentarsi, eppure l’esito è stato ben oltre quello aspettato e/o, appunto, preventivato. Non esistono più confini, barriere, politiche intellettuali, caste, élite. O almeno non esistono più in quelle che ne erano le vesti originali, abiti facilmente riconoscibili e per questo da cui era plausibile e possibile mettersi in guardia. L’uomo analogico con le sue verità diventa così sfocato, instabile, mobile e non più immobile. Distinguere tra verità e menzogna diventa estremamente complesso. Tutto si riduce a un “game” in cui ci sono partite da vincere. Finiamo con l’essere bombardati dallo stesso gioco, dallo stesso sistema. Fatichiamo a distinguere le notizie false dalle vere, siamo oggetto di pubblicità e propagande continue, finiamo con l’essere strumentalizzati dai nuovi poteri, ci perdiamo con problemi e questioni a cui precedentemente mai avremmo dato lo stesso peso, fino a renderci assuefatti al meccanismo che distrugge le nostre cellule celebrali riducendoci ad organismi plasmabili ad immagine e somiglianza dei potenti di turno. Perché la politica stessa ha sfruttato questo meccanismo e senza difficoltà continua a sbatterci la nostra stessa cecità sotto al naso. Il tutto volontariamente. Perché siamo noi i primi a volere questo, siamo noi i primi a non ribellarci a questo. In parte perché non ci rendiamo conto del pericolo, in parte perché abbiamo perso lo stimolo e/o la voglia di combattere con qualsiasi arma che sia diversa da un click su uno schermo o su un social. Si afferma così l’individualismo di massa che si sostituisce all’individualismo dell’io, si affermano le nuove élite, il tutto assume nuove forme e si afferma una vera e propria seconda guerra di resistenza di pochi.
Questo e molto altro è “The game”. Un saggio di grande intensità che ricostruisce gli ultimi 50 anni di storia umana evidenziando i pro e i contro dell’innovazione tecnologica, senza la pretesa di trovare risposte alle domande, senza obbligare alcuno a conformarsi o meno alla tesi proposta, eppure obbligando il lettore a confrontarvisi. Sta di fatto che il testo è ricco di spunti di riflessione, è devastante nella sua analisi e ricostruzione, è intelligente nella sua analisi e ricostruzione. Non risparmia niente. Nulla è esente dalla ricostruzione. Dalla politica, alle contraddizioni umane, alla volontà del singolo, al populismo diffuso, alla facilità con cui vengono scelte le strade più semplici a discapito delle più ardue, al modo in cui uno strumento dell’evoluzione e del sapere è fuggito dal controllo del suo stesso ideatore. Si può amare, si può odiare, ma non si può negare. Baricco riesce in un’impresa senza eguali e dona al conoscitore un elaborato stratificato che non delude le aspettative.
Indicazioni utili
IL PREZZO DEL SOGNO
Una dozzina d’anni fa Gabriele Muccino girò in America un film intitolato “La ricerca della felicità”. Questa pellicola, al di là del suo effettivo valore artistico, aveva il pregio di mettere al centro della trama quello che ritengo sia il fulcro dell’american way of life, ossia il diritto-dovere di lottare per migliorare la propria condizione personale e di ottenere, grazie esclusivamente alle proprie forze, al proprio ingegno e al proprio lavoro, il successo e l’affermazione sociale, la felicità appunto. Se il cinema hollywoodiano, che fin dalle sue origini ama flirtare con l’happy ending, è sempre stato pieno, da Frank Capra fino ai giorni nostri, di storie che si concludono con l’esaltazione apologetica del sogno americano, la letteratura statunitense è stata al contrario maggiormente critica nei confronti di questo sogno, a cui ha spesso (basti pensare a Steinbeck, per fare un solo nome) attribuito le fattezze di una illusoria e crudele chimera. Grossomodo a metà strada si situa l’ultima voce della narrativa d’oltreoceano, Imbolo Mbue, camerunense d’origine e americana d’adozione, che con “Siamo noi i sognatori” (vincitore nel 2017 del PEN/Faulkner Fiction Award) ha voluto dare la sua personale versione dell’american dream. Il suo libro racconta l’odissea della famiglia Jonga, emigrata in America in cerca di fortuna e di migliori opportunità per i propri figli, ma la cui condizione “irregolare”, dovuta alle difficoltà di entrare in possesso della agognata green card e di ottenere in tal modo la cittadinanza americana, la espone a tutte le incertezze e le traversie che al giorno d’oggi accomunano i migranti di tutto il mondo e che i notiziari televisivi continuano quotidianamente a portare, nella loro crudezza, fin dentro le nostre case. Il capofamiglia, Jende, riesce all’inizio del romanzo a ottenere un ben remunerato impiego come autista al servizio di un facoltoso dirigente finanziario di Wall Street, e questo colpo di fortuna sembra indirizzare positivamente i destini della famiglia: le entrate permettono di mettere da parte dei risparmi per i tempi bui, di pagare gli studi della moglie Neni per diventare farmacista e di togliersi perfino dei piccoli sfizi. Al primogenito Liomi si aggiunge una seconda figlia, e l’America appare davvero il paese dove scorrono “latte, miele e libertà”. La crisi economica è però in agguato (siamo nel 2008, e il datore di lavoro di Jende lavora proprio per quella Lehman Brothers il cui fallimento è stato all’origine della più lunga e devastante recessione mondiale dopo quella del 1929) e l’Ufficio Immigrazione tenta in ogni modo di mettere i bastoni tra le ruote del sogno dei Jonga di diventare cittadini americani.
Se nel romanzo della Mbue gli agili e brevi capitoli seguono alternativamente le vicende di Jende e di Neni, raccontando gioie e dolori della loro vita newyorkese, altrettanto vivide si stagliano le figure deuteragonistiche dei coniugi Edwards, Clark e Cindy, le cui telefonate private, gli sfoghi emotivi e perfino le confessioni intime Jende ha modo di ascoltare mentre accompagna il marito alle riunioni di lavoro e la moglie ai pranzi con le amiche. Quando Neni viene a sua volta assunta come domestica e bambinaia per un’estate, ella diviene addirittura una preziosa confidente della ricca e avvenente padrona di casa, lenendo con premurosa sollecitudine la sue angosce. Ben presto si scopre infatti che dietro alla sfarzosa vita degli Edwards (con domestici e autisti che si prendono cura di loro ad ogni ora del giorno, un appartamento nell’Upper East Side e una seconda casa negli Hamptons) non tutto è perfetto come sembra: Clark passa la maggior parte del tempo lontano dalla famiglia e sfoga lo stress lavorativo per mezzo di incontri clandestini con escort di lusso; Cindy annega la sua depressione nell’alcool e nelle pillole; il figlio primogenito Vince manda provocatoriamente all’aria gli ambiziosi piani predisposti per lui dai genitori per andare in India in cerca di pace e di spiritualità. Insomma, se uno degli intenti delle soap opera era, lo ricordiamo, quello di dimostrare che “anche i ricchi piangono”, beh, allora il libro della Mbue può assomigliare un po’ anch’esso a una soap.
In realtà l’approccio scelto in “Siamo noi i sognatori” è molto più problematico di quanto appaia ad una frettolosa lettura. La scrittrice afro-americana riesce infatti nell’intento di analizzare con intelligenza (ed anche una insospettabile leggerezza) la struttura dei rapporti economici del mondo del XXI secolo, un mondo spietato e iniquo che invita chiunque a entrare per assaporare le delizie della società consumistica, ma che, nella sua apparente democraticità, non fa che perpetuare le disuguaglianze e le disparità sociali, a partire dal significato stesso che per ciascuno dei personaggi ha il lavoro. Per gli Edwards esso è il mezzo per mantenere i propri privilegi e i propri status symbol, per i Jonga è l’unica possibilità per non perdere il diritto a rimanere in America e, evitando l’espulsione, a garantire ai propri figli un futuro dignitoso. Anche la crisi economica non è uguale per tutti. Se per gli Ewards essa significa un abbassamento temporaneo del tenore di vita, per i Jonga è invece la rovina completa, il fallimento. Viene qui adombrata in chiave contemporanea la concezione marxista della storia, con la sua divisione della società per classi, il carattere eminentemente transazionale dei rapporti umani e l’alienazione sociale che si riflette persino nelle vite private (“Per la prima volta nella loro lunga storia d’amore ebbe paura che la picchiasse. Era quasi certa che l’avrebbe picchiata. E se l’avesse fatto, avrebbe saputo che non era il suo Jende che la picchiava, ma un essere grottesco creato dalle sofferenze di una vita da immigrato in America.”). C’è una differenza sostanziale, però, rispetto al marxismo: da parte delle classi sociali più povere, degli immigrati e del sottoproletariato urbano vi è una adesione incondizionata all’american way of life, e mai si intuisce alcuna autentica velleità trasformatrice della società. Il signor Edwards è il modello a cui la famiglia di Jende aspira (“un giorno diventerai un pezzo grosso di Wall Street come il signor Edwards”, confida Neni al figlio), e neppure l’improvviso e inopinato licenziamento è in grado di mettere in discussione questa granitica certezza. Anche quando Neni decide di venire sorprendentemente meno ai propri valori morali per salvare la propria famiglia a spese della signora Edwards, non c’è in questa scelta alcuna rivendicazione ideologica né tantomeno alcun rancore personale represso, ma semplicemente un disperato espediente alla Filumena Marturano.
Non posso negare che il romanzo della Mbue soffra di un certo didascalismo di fondo. Si prenda ad esempio il sogno premonitore di Jende, in cui gli imbroglioni che hanno truffato la madre dell’amico prefigurano gli speculatori di Wall Street che con i subprime e i derivati hanno rovinato decine di migliaia di risparmiatori. Viene poi accennato (anche se ironicamente smentito) un parallelismo tra l’America della crisi economica e l’Egitto delle bibliche piaghe, come se le due calamità siano state un comune castigo nei confronti di chi aveva “preferito la ricchezza alla rettitudine, la rapacità alla giustizia”. Anche al netto di certe ovvie semplificazioni, ritenute evidentemente necessarie per far comprendere al lettore medio gli effetti sul mondo reale di una crisi finanziaria epocale (ad esempio, il meccanismo perverso dei prestiti che le banche concedevano largamente prima del 2008 anche a chi non poteva concedere alcuna garanzia viene sintetizzato nel caso di un amico di Jende, il quale perde la casa non potendo più pagare le rate del mutuo), “Siamo noi i sognatori” è un’opera che vanta una discreta complessità psicologica. La perdita del posto di lavoro, l’improvviso abbassamento del tenore di vita e, soprattutto, la paura di dover abbandonare gli Stati Uniti per sempre, innescano nei coniugi Jonga una serie di reazioni non scontate, di dolorosi adattamenti alla realtà, di metamorfosi caratteriali (anche nei rapporti reciproci), che portano Jende e Neni alla fine del romanzo ad essere molto diversi dalle figure candide e ingenue che erano all’inizio (Neni arriva a pensare di divorziare dal marito e fare un matrimonio di convenienza con un americano pur di ottenere la cittadinanza, o addirittura di dare in adozione il figlio per permettergli di continuare a vivere negli Stati Uniti). La Mbue è sincera e parla di cose che evidentemente conosce molto bene, dal momento che molte peripezie passate dai protagonisti devono anche essere state le sue, da quando, diciassettenne, mise per la prima volta piede negli Stati Uniti. La sua prosa semplice e scorrevole, abbastanza elementare nella sintassi e nel lessico (con il ricorso frequente a termini africani), è comunque efficace (nonostante qualche buonismo di troppo) nel costruire personaggi di notevole spessore (soprattutto quelli femminili di Neni e Cindy, dolorosamente sfaccettati, a fronte di una maggiore prevedibilità di quelli maschili) e nel mettere a confronto (a volte anche con effetti che rasentano l’umorismo) due culture così diverse e per certi versi inconciliabili come quella occidentale e quella africana. Il finale conciliatorio, che sembra contraddire il cinismo di altre parti del romanzo, non deve trarre in inganno. Quella che risuona nella testa del lettore, una volta chiuso il libro, è soprattutto una domanda (che la situazione dell’America odierna, in cui a Obama è succeduto Trump, rende ancora più pressante): se il sogno americano è quello descritto dalla Mbue, valeva davvero la pena sognarlo?
| 1719 risultati - visualizzati 401 - 450 | « 1 ... 6 7 8 9 10 11 ... 12 35 » |